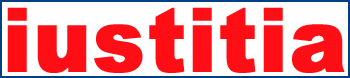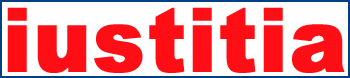| Carissimi,
non so se sia lecito intervenire così da lontano e dalla situazione in cui mi trovo. Ma non posso stare a vedere, in una situazione come questa e neanche scrivere editoriali al buio. Molti di voi mi hanno detto: come ti possiamo aiutare? Coinvolgendomi. Mi pesa molto essere in un altro mondo e separata.
Non è una crisi finanziaria come le molte che abbiamo passato. Forse non erano solo finanziarie neanche loro. Perdere lettori non è solo un problema di soldi. Non lo è neanche quello che sta patendo qui Liberation. Ve ne ho scritto qualche tempo fa, non ho avuto reazioni. Non vi torno sopra - anche se qualcosa correggerei: mi ha fatto pensare il numero sui 35 anni.
Ma per sapere quale crisi sia, verifichiamo il giudizio che diamo sulle sue cause. In mancanza di questo, mi sfugge che cosa Marco, Stefania e Ida vogliono dire con segnale di discontinuità. Le discontinuità possono andare in varie direzioni.
Il giornale ha cambiato fisionomia più volte: reazione d’un corpo vivo al mutare precipitoso delle cose. E’ stata ogni volta una fatica e ha comportato divisioni più o meno esplicite. Ma non credo che siamo stati ciechi di fronte a quel che cambiava – nel 1989, o nel 1994, o nel 1996, o l’11 settembre 2001 e poi le guerre e i governi. Abbiamo concesso molto al darci tempo, garantendoci una libertà reciproca in una fase di incertezza, per cui si è presto privilegiato l’essere in comune rispetto a quel che in comune volevamo conseguire.
Ma ho sempre pensato, come Luigi, che se un giornale è una forma della politica, deve esporsi con chiarezza: il manifesto dice “sta avvenendo questo, questo è il trend, questo bisogna fare a breve e questo a lungo termine”. Riflettendo assieme, non ciascuno rispondendo a modo suo e affiancando un pezzo all’altro senza una discussione esplicita. Forse un tempo di decantazione ci voleva. Ma le pensate singole non hanno più un grande fascino. Anzitutto, per geniali che siamo, ci ripetiamo. In secondo luogo il quadro politico si va così ricomponendo in una oscillazione fra destra e centro (e non solo in Italia) che per essere necessari almeno a una minoranza intelligente dobbiamo presentare una tesi non parziale su questo trend, non semplificandone le cause.
Sento che i più sarebbero demotivati. Proprio mentre la storia precipita e c’è tutto da conoscere e far conoscere? Ma dunque in che si era sperato? E dove si sbagliava?
Da questo perdersi derivano anche le scelte che alcuni vanno compiendo, o in direzione di Rifondazione (quella attuale) o di collaborazione a qualche ministero. Non do’ alcun giudizio politico o morale; dico che siamo a questo. Per altri, il giornale è solo un posto di lavoro, verso il quale provano anche qualche risentimento.
Risultato: siamo un giornale debole che parla diverse lingue.
Veniamo al concreto. Adesso che Berlusconi è fuori dai piedi e un diviso centrosinistra è al governo, vogliamo che questo governo duri almeno fino a quando una sua caduta non riporti a Palazzo Chigi la Cdl o un centro ricostituito, e ci sia una capacità di opposizione non marginale? O troviamo inesorabile che il governo d’ora in poi passi, come negli Stati Uniti e in Germania o altrove, al bipolarismo “perfetto”, fra un partito di destra (senza Lega) e un partito democratico (possibilmente senza Rifondazione) e a noi resti da fare il Nader o il Chomski della situazione? O di inserirci nella sinistra del centrosinistra, diventando una specie di Riformista di senso opposto?O diveniamo un foglio dei movimenti, o parasindacale, o culturale senza agganci politici, che punta a una ricerca per la quale però un quotidiano non è la sede più adatta?
Non ci sono altre scelte. Se ci sono, si dicano con chiarezza.
Credo sia preliminare la verifica di come il collettivo giudica la situazione di fase. Avanzo alcune questioni credo controverse. E vorrei che si rispondesse. Per iscritto, per email (d.ricci@ilmanifesto.it).
1.
a. Nessuno di noi propone di tornare al 1971. Dalle frecciate rivolte a me sulla fine delle politiche del secolo scorso ho tratto allegramente il titolo del mio libro. Credo di aver liquidato la linea del Pci dai Sessanta in poi in modo opposto ai Diesse, ma chiudo col 1969 perché dopo “è un’altra storia”. Questa è da fare. Sì, no, il problema è un altro?
La storia non si misura soltanto con i successi e gli insuccessi; la Rivoluzione Francese è finita malissimo ma ha cambiato le strutture politiche del secolo, e oltre. Si può dire lo stesso del 1917, di Lenin, dei “movimenti antisistema”? Sì, no, il problema è un altro?
b. Per capire il presente bisogna capire il passato. O no? Dei “socialismi” nulla vale la pena di essere esaminato? I tentativi di uscita dal capitalismo potevano andare diversamente? Se sì, dove è stato l’errore? Di chi? Da quando?
Oppure non poteva che finire così, ha ragione Fukujama, la storia che si poteva andare a un altro modo di produzione è stata un abbaglio? Se invece il comunismo è ancora una prospettiva, quale comunismo?Come la mettiamo con Marx? Come Finelli? Come Badiou? Come Negri? O non vale più la pena di metterla?
Se non vale più la pena, dove stiamo andando? “Socialismo o Barbarie” era uno slogan sbagliato? Che diremmo oggi?
c. Adesso, se il presente è l’impero, come si spiega Bush? Anche se la sua è stata una sorta di colpo di stato, ne sono uscitiesasperati i conflitti e alcuni resi irresolvibili. O no?
La guerra è tornata, ma diversa e più asimmetrica che mai.E’ un incidente o un elemento costituente?Come si è modificata? Wallerstein pensa che siamo tornati – in senso proprio regrediti – alle guerre commerciali. Se sì,dobbiamo vedere come il vorticoso intreccio, crollo, cambio e fusione di proprietà sia diventato un asse portante delle politiche estere. In questo caso la crisi dello stato nazione è più vasta di quel che si pensava, gli stati diventano un’agenzia dei grandi flussi economici e finanziari, cercando di appropriarsene un po’. Questo vale anche per l’Onu e la Ue. O non è vero?
E in ogni modo c’è stato e stato. Sui flussi mondiali altro è il peso degli Stati Uniti rispetto a tutti gli altri. E la differenza maggiore è la forza del loro armamento e la decisione di intervenire dovunque credono. E’ un incidente di percorso della storia americana? Perché l’Europa l’accetta, perdendo ogni ruolo in Medio oriente?
Che sarebbe una politica per la pace non fatta di sfilate e pii desideri? Si può garantire la pace “senza prendere il potere”?
d. Se il presente mantiene dei tratti di vecchio imperialismo, quali contraddizioni esso cela o comporta? Che cosa è la Cina e che cosa sta cercando di diventare la Russia? Che cosa sono i progressismi nazionalisti sudamericani, che non si presentano per la prima volta? Che cosa sono le “rivoluzioni arancione”? Che posto riprendono le materie prime, la produzione di energia, i conflitti relativi? Che è diventata la contraddizione nord-sud?
e. Se la vittoria del capitalismo è il dato da cui partire, qual è la sua figura antagonista? il proletariato è finito, è un residuo (come nei frammenti che in Italia incontriamo un po’ dovunque) oppure i consumi nascondono che esso si sta allargando nel resto del mondo, e si estende la sfera delle società messe al lavoro e allo sfruttamento?
Su quali “antagonismi” poniamo l’accento? Su una internazionalizzazione del proletariato vecchio e nuovo? Sulle moltitudini? Sui movimenti? Su nuove figure sociali? Sul crash di civiltà? Con l’esodo? Con l’esodo femminile?
d. Vorrei anche che finissimo di parlare di crisi della politica, senza dire di quali altre forme si delinea la necessità. Di crisi della rappresentanza, se non diciamo che cosa le va sostituito per non cadere in forme neonaziste o talibane. Di sottacere lo stato di panne dell’Europa che a qualcuno di noi pare un bene, ad altri un male.
Sono solo alcune domande, dalle quali dipendono anche le scelte in tempi strettissimi.
2.
Del problema finanziario ho già scritto in settembre. Non mi pare che se ne sia discusso. Non ho capito bene, dagli appunti finora mandati, quali soluzioni sono proposte ora, se non, da Valentino, un intervento sui prezzi e poi lo stato di crisi. Non so. A stare all’istinto non alzerei il prezzo in un periodo così sciagurato come è l’estate. Mi persuade solo che occorre cercare i soldi. Ma anche se funziona è un rappezzo.
Mantengo la proposta che ho fatto a settembre, un poco addolcita, sulla base di una non sostenibilità del rapporto fra i costi e i ricavi di questo giornale, l’imponenza della macchina produttiva e lo scarso numero dei lettori.
Non so come si possa dire che un’azienda ha l’esercizio in pareggio ma l’indebitamento la affoga: o se si può, è a costo di non pagare prima gli stipendi e poi i fornitori. E trovarci come ora con l’acqua alla gola.
Direzione e Cda devono o ristrutturare o chiudere.
Penso a un giornale più leggero, più persuaso, più completo, più ordinato, più economico. Un giornale che non sia un posto di lavoro per chi non ne ha altri e tanto meno sia un secondo lavoro. Un giornale il cui bilancio riparta da un equilibrio fra entrate e uscite, recupero del debito incluso.
Il giornale cui penso potrebbe uscire cinque giorni alla settimana, saltando domenica e lunedì. (A meno di un supplemento sportivo). Con un orario a 35 ore settimanali effettive.
Potrebbe avere otto pagine fitte (dieci con tv, cinema e appuntamenti locali).
I supplementi potrebbero essere di quattro, sei o otto pagine, tematici: globalizzazione (economia, proprietà e lavoro), movimenti e politiche extraistituzionali; cultura e libri; società e consumi; Alias (o simili).
Otto pagine fatte di quotidianità immediata e dell’attuale pagina 2 non sono poche; il notiziario politico, sindacale e globale del Corriere e di Repubblica, con molti bianchi e molte lungaggini, non va oltre.
Un giornale come questo dovrebbe avere una squadra fortemente responsabilizzata, composta da 16 a20 persone più il desk per il quotidiano, e non più di quattro per ogni supplemento.
Nei supplementi le persone dovrebbero avere uno statuto contrattuale diverso, considerando la maggiore elasticità dei tempi, e diverso da quello di chi collabora con scritti o rubriche.
Sarebbe un taglio energico, da costruire attorno a un progetto politico, un sistema di regole e un collegio arbitrale per il loro controllo e eventuali sanzioni. Direzione, Cda e organizzazione del lavoro precisi.
Non ho la possibilità di proporre nulla di simile per l’amministrazione e i servizi, ma non dovrebbe essere impossibile.
Credo che questo taglio ci dovrebbe permettere un bilancio in pareggio con una progressiva diminuzione del debito e qualche surplus per le iniziative.
Scusate la brutalità. Ma preferisco che per una volta ci parliamo con chiarezza.
|