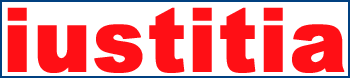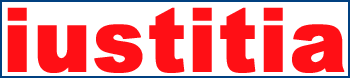Il giornalista Pierluigi Roesler Franz sta lavorando a una pubblicazione sugli ottantatre giornalisti italiani caduti durante la prima guerra mondiale. Pubblichiamo le schede relative ai dieci cronisti nati o vissuti in Campania o che scrivevano per giornali della Campania
1) Antonino o Nino o Nino Florio CARAVAGLIOS - Medaglia d’argento al valor militare alla memoria
Nato il 4 marzo 1889 ad Alcamo (Trapani). Figlio di Raffaele. Sottotenente della milizia territoriale del 21° reggimento fanteria della Brigata Cremona. Morto il primo novembre 1916 sul Carso a Doberdò (Gorizia) per le gravi ferite riportate in combattimento. Una sua foto è pubblicata sulla rivista "La Luce nel pensiero" supplemento al fascicolo del settembre 1913 a pagina 23.
Diplomato al Conservatorio musicale di San Pietro a Maiella, laureato in Giurisprudenza, diplomato in Scienze consolari, avvocato, direttore d'orchestra, critico musicale e studioso di storia della musica, giornalista e agguerrito polemista.
Conseguì la laurea in Giurisprudenza e scrisse un manuale di Diritto ecclesiastico e un compendio di Medicina legale; ma sulla scia del padre Raffaele (che dirigeva la banda musicale di Napoli ed era considerato una vera istituzione nell'attività bandistica napoletana e che compose nel 1913 "L'inno dei giornalisti" che nel 2008 fu eseguito al Teatro Capranica di Roma in occasione del primo centenario della Fnsi), si dedicò anche alla musica sia sotto l'aspetto storico-critico che creativo, tanto da contribuire al movimento futurista in questo ambito. Da futurista convinto fece conoscere per la prima volta a Napoli nel 1910 alcuni brani di Mussorgskij e alcune composizioni di Elgar. Figlio d'arte ha composto la musica di canzonette dialettali apparse nei fascicoli di Piedigrotta campagnola nel 1912 e 1913.
Fu anche direttore de "I ribelli", introvabile rivista d'avanguardia. Collaborò con varie riviste: "La Rivista musicale italiana", "Il Domani", "Aprutium", "Eco della Cultura", "Vela latina". Perì nella Grande Guerra. Gli è stata intitolata una via ad Alcamo (Trapani) sua città natale.
A Napoli sulla facciata del palazzo di via Carbonara 83 A il Comune ha posto nel 1923 una lapide in cui si legge: “A Nino Caravaglios assurto alla gloria nel primo novembre MCMXVI a Doberdò in atto di supremo eroismo – Sulle pareti di questa casa donde mosse deponendo lo studio delle leggi ma portando seco l’anima musicale che vibrò nella virtù del sacrificio estremo ritorna col suo nome come in un sublime rigurgito la poesia della sua giovinezza infranta - NAPOLI MCMXXIII”.
2) Arturo CARUSO - “L’Ordine” - Medaglia d’argento al valor militare alla memoria
Nato il 22 settembre 1883 ad Acerra (Napoli). Figlio di Filippo. Tenente di complemento del 122° reggimento fanteria della Brigata Macerata. Morto il 26 luglio 1915 sul Carso a Polazzo (Redipuglia) per le gravi ferite riportate in combattimento.
3) Vittorio COTRONEI - “Il Mattino”
Nato il 17 gennaio 1893 a Napoli. Figlio di Giuseppe. Sottotenente di complemento del 157° reggimento fanteria della Brigata Liguria. Morto il 15 novembre 1915 sul fronte dell’Isonzo a Potoce sul Massiccio del Monte Nero (Krn, oggi in Slovenia).
La notizia della sua morte é riportata il 15 ottobre 1916 sul frontespizio del periodico settimanale "La Guerra Italiana", pubblicazione della Casa Editrice Sonzogno di Milano, tra i giornalisti caduti al fronte nel primo conflitto mondiale.
Il 4 novembre 1921 (stesso giorno della cerimonia a Roma di tumulazione del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria) Cotronei fu commemorato presso l'Associazione della Stampa a Roma insieme agli altri giornalisti caduti (all’epoca se ne conoscevano, però, solo 46). Il suo nome compare appunto a pag. 217 del XIX capitolo "Giornalisti soldati" del libro "Giornalismo eroico" di Arturo Lancellotti, Edizioni Fiamma, Roma, 1924 di 264 pagine oltre a sette pagine di prefazione di Giovanni Biadene, segretario generale della Federazione giornalistica italiana, consultabile in 49 biblioteche italiane tra cui la Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma. Fu cronista e redattore de “Il Mattino” di Napoli dove si occupava, oltre che della cronaca, di “questioni critiche ed estetiche”. Socio dell’Unione giornalisti napoletani. Frequentò il corso allievi sottufficiali di fanteria di Modena. Ne uscì con il grado di sottotenente e raggiunse subito il suo reggimento al fronte dell’Isonzo, cadendo pochi giorni dopo valorosamente. Suo fratello Adolfo era, invece, un giornalista de Il Corriere della Sera.
4) Felice DE MASI - “Il Mattino”
Il 4 novembre 1921 (stesso giorno della cerimonia a Roma di tumulazione del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria) De Masi fu commemorato presso l'Associazione della stampa a Roma insieme agli altri giornalisti caduti (all’epoca se ne conoscevano, però, solo 46). Il suo nome compare appunto a pag. 217 del XIX capitolo "Giornalisti soldati" del libro "Giornalismo eroico" di Arturo Lancellotti.
5) Carlo FAVA - “Roma” di Napoli
Nato il 22 luglio 1880 a Napoli. Figlio di Francesco. Soldato del 63° reggimento fanteria della Brigata Cagliari. Morto il 15 febbraio 1917 in seguito all'affondamento del piroscafo "Minas" diretto a Salonicco, tragedia avvenuta a 180 miglia dalla costa nei pressi di Capo Matapan (punta estrema a sud della penisola del Peloponneso in Grecia). Era reporter de “Il Roma” di Napoli.
Al terzo giorno di navigazione la nave, che trasportava un notevole contingente di truppe italiane, francesi e serbe, fu colpita da due siluri lanciati dal sommergibile tedesco U 39 al comando del capitano Walter Forstmann alla posizione 36°25’N – 18°24’E. E s’inabissò provocando al morte di ben 870 persone, tra i quali anche Vittorio Locchi di Figline Valdarno, il
“poeta -soldato”, noto per il poemetto “la Sagra di Santa Gorizia” (il manoscritto, che era stato spedito dal poeta ad Ada Negri, la quale lo consegnò poi a Ettore Cozzani affinché lo pubblicasse nei "Gioielli dell'Eroica", ebbe uno straordinario successo tanto da giungere nel 1956 alla 14^ edizione e fu letto in tutto il fronte, nelle prime linee e nelle retrovie. Definita dal Cozzani "canto dell'eroico patimento", la "Sagra di Santa Gorizia" resterà una delle opere più belle e significative scritte sulle vicende della città). Sembra che a bordo della motonave Minas vi fosse anche un notevole carico di lingotti d'oro (25 cassette) finito così in fondo al mar Egeo.
6) Mario GIAMPIETRO - “Don Marzio”
Nato il 27 aprile 1888 a Napoli. Figlio di Luigi. Sottotenente del 129° reggimento fanteria della Brigata Perugia. Morto il 30 ottobre 1915 nell’ospedale da campo n. 9 dopo essere rimasto gravemente ferito in combattimento su Monte San Michele. La notizia della sua morte é riportata il 15 ottobre 1916 sul frontespizio del periodico settimanale "La Guerra Italiana", pubblicato dalla Casa Editrice Sonzogno di Milano, tra i giornalisti caduti al fronte nel primo conflitto mondiale.
Il 4 novembre 1921 (stesso giorno della cerimonia a Roma di tumulazione del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria) Giampietro fu commemorato presso l'Associazione della stampa a Roma insieme agli altri giornalisti caduti (all’epoca se ne conoscevano, però, solo 46). Il suo nome compare appunto a pag. 218 del XIX capitolo "Giornalisti soldati" del libro "Giornalismo eroico" di Arturo Lancellotti. Apparteneva a una famiglia assai benemerita della patria. Socio dell’Unione giornalisti napoletani. Redattore del “Don Marzio”, giornale napoletano comico-satirico, fondato da Luigi Pappalardo nell’ottobre del 1860. Morto il Pappalardo nel 1863, la direzione passò a Raffaele Villari (fino al 1871). Il giornale si pubblicava dieci volte al mese. Prezzo di associazione: 18 tarì per un anno; 10 tarì per sei mesi. Un numero costava 7 centesimi. Oltre a Villari vi collaborarono Stefano Ribera, Michelangelo Bottri, Giuseppe Romeo Pavone. Dal 3 all’11 marzo 1861 pubblicò cinque numeri con i diari dei bombardamenti della Cittadella assediata dalle truppe del generale Medici. Eugenio Sacerdoti fu direttore del Don Marzio nel 1893.
7) Renato GIOVANNETTI - “La Vita, Napoli”
Nato il 19 agosto 1892 a Roma. Figlio unico di Achille e di donna Maria Carutti, vice presidente del Comitato sabino di lotta antitubercolare. Capitano (già tenente) del 271° reggimento fanteria della Brigata Potenza (la sua promozione era in corso ed apparve postuma sul Bollettino dell’8 novembre 1917). Comandante della 9^ compagnia. Morto il 26 agosto 1917 sull’altopiano di Kal (parte settentrionale dell’altopiano della Bainsizza) nell’11^ battaglia dell’Isonzo colpito in fronte da una pallottola esplodente.
Iniziò a scrivere sin da bambino sempre amorevolmente assistito da sua mamma con cui faceva i compiti e alla quale era particolarmente legato, essendo figlio unico. A nove anni entrò nel liceo-ginnasio Torquato Tasso e vi compì gli studi classici. Nel 1914 si laureò in Giurisprudenza con 102 su 110 con una tesi sulla “Diffamazione a mezzo della stampa e i progetti di riforma delle disposizioni vigenti”, tesi che rispondeva a tutto il piano armonico della sua vita di giornalista nato. Infatti già durante la vita universitaria, essendo impiegato nel Comitato per i festeggiamenti del 1911, fra artisti, pubblicisti e letterati, crebbe e si ingigantì in lui la passione per il giornalismo perché non si sarebbe mai adattato alle pastoie di una professione burocratica.
A soli 19 anni divenne giornalista de “La Vita” di Napoli e ne fu uno dei suoi più apprezzati redattori ordinari, riscuotendo la stima e la considerazione di Luigi e Olga Lodi. Fu mandato come inviato speciale all’Isola d’Elba a un convegno giornalistico per visitare il “paese del ferro”. Collaborò anche con il “Giornale d’Italia”. Vi è di lui una ponderosa produzione letteraria giornalistica. Pubblicista, era socio dell’Associazione stampa romana. Allo scoppio della guerra partì col grado di sottotenente per raggiungere un battaglione in formazione in Piemonte. Fu poi mandato al Tonale e l’Adamello e quindi in Val di Ledro nelle posizioni più avanzate, finché nel giugno 1917 prese parte all’avanzata sulla Bainsizza raggiungendo l’altipiano di Kal. Quando seppe che il suo 271° reggimento aveva formato con altri due la nuova Brigata Potenza così aveva scritto a sua madre: ”Possa il duplice significato del nome essere di buon augurio per i fasti del mio reggimento”. Il 26 agosto 1917 a soli 25 anni trovò gloriosamente la morte.
La sintesi dell’eroico episodio è data dal comando del 271° fanteria: “Il tenente Renato Giovannetti cadde da vero eroe alla testa della sua 9^ compagnia nelle prime ore del mattino del 26 agosto nell’altipiano di Kal, parte settentrionale dell’altipiano della Bainsizza. Fu il primo tra i primi veramente animosi a scattare contro il nemico che opponeva un’accanita, tenacissima resistenza al nostro incalzare con innumerevoli mitragliatrici sparanti con pallottole esplodenti – lealtà internazionale! – e con lancio intensissimo di bombe a mano di tutte le specie. Il balzo in avanti ebbe esito; ma il povero indimenticabile tenente Giovannetti rimaneva colpito alla fronte da una pallottola esplodente oltre la linea nella quale condusse il balzo dov’Egli con irresistibile ardente impulso entusiastico si era spinto. Visse pochi minuti senza profferire alcuna parola. I presenti raccontano commossi di tutta la fierezza che negli estremi istanti della vita si sprigionava calma dal di lui sguardo. Non fu possibile ricuperare la salma per l’intenso fuoco che persistette ad infuriare senza interruzione. Vero esempio di fulgido eroismo, tutti i colleghi ufficiali e la truppa da cui era conosciuto, lo ricordano con simpatia vivissima, indimenticabilmente”.
Appena due giorni prima di morire e dopo aver marciato per 22 ore aveva scritto a sua mamma: “La gioia dei felici successi riportati nella nostra zona ci rende men dure anche le più atroci fatiche e i maggiori sacrifici”. Ed ancora: “Che dirti, mammuccia mia cara, in quest’ora? Non è il momento di parole, né saprei trovarle nelle condizioni presenti. Ti dirò che sono con te minuto per minuto, cuore contro cuore, anima contro anima, spirito contro spirito. Del resto la tua benedizione e il tuo augurio mi accompagnano e son certo che non mi accadrà nulla…Tutta la mia anima in un forte bacio”.
Ad un ufficiale suo amico che gli parlava di avvenire , rispondeva: “Io porto a mia madre una venerazione sconfinata e non è certo questo il momento di parlare di simili cose ad una donna che, sola, aspetta il ritorno del suo unico bene e che lo sa da due anni sull’orlo del sanguinoso abisso. Ogni parola che non fosse esclusivamente a lei rivolta suonerebbe oltraggio”.
Qualche mese prima aveva confidato allo zio materno il suo pensiero sull’eventualità della morte e su quello che avrebbe dovuto sopportare la mamma Maria: “Sarebbe una spaventosa prova, ma so di quale tempra la fiamma dell’amor patrio ha rinsaldato quel cuore: l’orgoglio del tremendo sacrificio ideale e materiale vincerebbe lo smisurato dolore umano…Anche su questo dunque sono tranquillo!”
Il 4 novembre 1921 (stesso giorno della cerimonia a Roma di tumulazione del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria) Giovannetti fu commemorato presso l'Associazione della stampa a Roma insieme agli altri giornalisti caduti (all’epoca se ne conoscevano, però, solo 46). Il suo nome compare, ma con l’erronea indicazione del cognome Giovannelli, appunto a pag. 218 del XIX capitolo "Giornalisti soldati" del libro "Giornalismo eroico" di Arturo Lancellotti. La sua giovane vita è narrata nel libro di 125 pagine “Alla fronte -Impressioni” con cenni biografici di Thomas Isidori, che raccoglie anche le sue lettere dal fronte, pubblicato nel 1918 a Poggio Mirteto dalla Società cooperativa tipografica sabina e messo in vendita a 4 lire a beneficio del Comitato intercomunale sabino per la lotta antitubercolare. Il volume è consultabile alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma e alla Biblioteca dell'Accademia delle scienze di Torino. Gli è stato intitolato alla memoria il Dispensario di Poggio Nativo (Rieti).
8) Roberto MARCIANO - “L’Ora” di Palermo
Nato il 19 dicembre 1891 a Napoli. Figlio di Ercole. Tenente del 73° reggimento fanteria della Brigata Lombardia. Morto il 26 maggio 1917 nell’ospedale da campo n. 44 dopo essere rimasto ferito sull’altopiano di Asiago. Era vice segretario dell’Associazione della stampa siciliana. Il suo più giovane fratello Renato (nato a Napoli il 7 febbraio 1896) per una singolare e sfortunata coincidenza morì appena 3 giorni prima di lui (il 23 maggio 1917) sul Monte Santo.
9) Enzo (Vincenzo Maria) PETRACCONE -“Il Giorno" di Napoli - Medaglia d’argento al valor militare alla memoria
Nato il 23 dicembre 1890 a Muro Lucano (Potenza). Figlio di Gerardo. Tenente della 129^ batteria dei bombardieri. Morto il 15 giugno 1918 sul monte Valbella sull'altipiano di Asiago. In un primo tempo era stato dato per disperso. Il suo corpo fu poi ritrovato, ma solo dopo parecchi mesi. Fu insignito di medaglia d'argento al valor militare alla memoria con questa motivazione: “Comandante di una posizione durante un irruzione nemica, avvisato del pericolo incombente, si spingeva arditamente con altro ufficiale oltre la linea dei pezzi per chiarire la situazione: accerchiato da nuclei di nemici, dopo accanita resistenza, cadde da prode sul campo”.
Scrittore, critico d’arte e giornalista. Fu grande amico e allievo di Benedetto Croce e lavorò al “Giorno”, diretto da Matilde Serao. Fu detto lo scrittore-soldato. Una delle più belle figure di eroi che la Basilicata abbia dato nella Grande guerra.
Come ricorda Giovanni Petraccone in un suo ampio articolo su “La Basilicata nel Mondo - 1924-1927) suo fratello Enzo "dimostrò sin dall’infanzia svegliatezza d’ingegno ed indole vivacissima: compiuti i primi studi nella città nativa, si trasferì per gli studi ginnasiali e liceali a Napoli ove frequentò il R. Liceo Antonio Genovesi, nel quale ora una lapide ne ricorda il nome tra quelli dei Caduti nella grande guerra che uscirono da quell’Istituto. Benché egli non potesse dirsi un ottimo scolaro, tuttavia dimostrò ben presto un grande amore per la lettura ed anche desidèrio di notorietà e di fama pur dicendo di non avere alcuna fiducia in sé stesso: era cioè già in lui una vena di scetticismo e di sfiducia nelle sue forze in contrasto col desiderio di esser qualcuno e con quanto andò a mano a mano facendo nel campo degli studi; scetticismo che culminerà in quei Colloqui col cane Tell, scritti al fronte, compenetrati di amara tristezza, ed anch’essi in contrasto con l’opera sua di ottimo soldato che si apprestava a dar la vita per la patria.
Laureatosi in lettere Petraccone fu, oltre che letterato, anche giornalista. Scrisse infatti per diversi quotidiani e settimanali tra cui “Il Secolo XIX”,” Il Mattino”, “Il Giorno”, diretto da Matilde Serao, "Il Giornale d’Italia”, la “Tribuna”, il “Fanfulla della Domenica”, e altre testate come“Orfeo”, il “Corriere del Vomero e di Posillipo”, “Noi e il Mondo”,”Emporium” e “Italia I”.
Scrisse diverse opere tra cui: “L'isola di Capri”, “La commedia dell'arte” (con prefazione di Benedetto Croce), “Luca Giordano”, “Cagliostro nella storia e nella leggenda”. Poco prima di partire per la guerra in cui doveva trovare morte gloriosa, aveva affidato al Croce un’interessante “Antologia de La Commedia dell’arte”, che fu poi magnificamente edita postuma da Riccardo Ricciardi.
Partì come volontario per la Prima guerra mondiale in cui trovò la morte. Con queste parole Benedetto Croce tracciò la sua fine gloriosa: “Così questo giovane che non ciarlava di politica, che non portava sulle labbra parole enfatiche, che si ammantava volentieri di freddezza e asseriva di non credere a nulla, andò forte e sereno a dare la sua vita per la patria e la dette in una memorabile giornata nella quale, per opera sua e degli altri a lui simili, furono restaurati l'onore e la fortuna d’Italia".
Del primo periodo della vita di Enzo Petraccone un suo maestro, Gioacchino Brognoligo, scrisse un commosso elogio del suo antico discepolo con un articolo dal titolo: “Lo scetticismo di un caduto per la patria" in cui lo ricorda così: “Un giorno, quando era ancora studente di prima liceale, a me, suo professore, egli disse che era un abulico: in lui era dunque una precoce naturalmente mal sicura e fallace, ma non per questo meno pronta, anzi per questo appunto più pronta a manifestarsi, conoscenza di sé che lo portava alla diffidenza delle sue forze e quindi, per un istintivo e assai giovanile bisogno di consolarsi della sua debolezza, generalizzandola ed obbiettivandola, allo scetticismo. Nello stesso tempo era in lui un gusto per tante cose, come ad esempio, per raccogliere libri antichi, cercare ed indagare vecchie cose e vecchie storie, per tentare varie esperienze, e questo gusto lo portava ad un’attività che l'assorbiva tutto e gl’impediva di manifestare lo scetticismo verso di sé, verso gli studi, verso la vita altrimenti che con qualche frase staccata e qualche risolino".
Fu proprio negli ultimi anni del liceo che Enzo Petraccone ebbe occasione di conoscere Benedetto Croce al quale si rivolse per averne consiglio ed aiuto in certe ricerche che Egli tentava sulla teoria e la storia delle leggende storiche; e fu senza dubbio l'incontro col Croce che decise della sua vocazione di scrittore. Si era in quel tempo pubblicata una monografia del Prezzolini, su Benedetto Croce, e fu appunto una recensione di tale libro il primo scritto di Petraccone che egli pubblicò sul “Fanfulla della Domenica”, giornale che anche dopo accolse altri suoi articoli. L’influenza benefica del Croce nell’indirizzarlo, nel consigliarlo, nell’aiutarlo si rivelò chiaramente negli anni seguenti e dette luogo ad una ammirazione affettuosa e cordiale del discepolo verso l'illustre Maestro e ad una deferente amicizia che doveva terminare solamente con la morte di Petraccone.
“Da allora” (cioè da quando l'editore Ricciardi glielo presentò nel 1909), scrive Benedetto Croce nella prefazione al Luca Giordano,“l'ho avuto a fianco quasi di continuo: studiava nella mia biblioteca, mi consultava per le sue indagini, si intratteneva con me quotidianamente accompagnandomi a passeggio. In quel primo tempo, com’è dei giovani, tentava vari generi di lavoro, esclusa peraltro la filosofia, sebbene il filosofare ed il dilettarsi nel filosofare fossero allora la nuova moda: era raccoglitore di libri rari e curiosi (me ne donò qualche centinaio di bizzarra letteratura secentesca, che mi riempiono ancora un paio di palchetti); frequentava pittori e altri artisti, e prendeva gusto alle arti figurative; conduceva ricerche storiche in biblioteche ed archivi, vagheggiava di comporre un romanzo e qualche parte ne scrisse, e poi ebbe sempre ritegno a mostrarmela, perché io celiavo con lui sui folti amori che ne formavano oggetto”.
Intanto, terminati gli studi liceali si era iscritto all’università, alla facoltà di Lettere ove fu caro ai suoi maestri e specialmente a Francesco Torraca che fu suo relatore all’esame di laurea. La tesi che egli presentò e discusse nell’ anno 1912 in cui si laureò, aveva per argomento “La Commedia dialettale napoletana del ‘700”,e il relativo manoscritto si conserva presso Benedetto Croce, il quale così ne scrisse: “Il tema che in essa trattava era rimasto fino allora del tutto negletto, ed egli l'aveva inteso nel giusto verso lumeggiando quella commedia napoletana, non buffonesca ma realistica (che precorse la commedia veneziana del Goldoni) come da una parte, un ricollegamento alla tradizione dialettale secentesca di Napoli, che vantava i nomi del Basile e del Cortese, e dall’altra un segno dei nuovi tempi, tendenti all’osservazione morale del costume e della società.
Fu in questo medesimo periodo che Petraccone preparò l’Antologia della Commedia dell’Arte che ha visto la luce postuma nel 1927 nella sontuosa edizione del Ricciardi. Essa ha riempito una vera lacuna nella letteratura degli studi sulla Commedia dell’Arte in quanto essa fornisce agli scrittori i testi di quella produzione artistica così spiccatamente italiana e raccoglie da stampe e manoscritti le antiche notizie intorno alla sua storia, dettate in gran parte dagli attori stessi, le regole e i modelli secondo cui le recite si disponevano e, infine, una serie dei più importanti “scenari” del Cinque e Seicento.
Mentre attendeva a queste ricerche ed a questi studi Petraccone fu attratto dal giornalismo e grazie sempre all’aiuto di Benedetto Croce fu accolto nella redazione del “Giorno”, diretto da quell’illustre scrittrice che era Matilde Serao, che lo ebbe carissimo e gli dedicò, dopo la morte, parole di affettuoso e sincero compianto. E numerosi articoli di vario genere, sempre accurati nella forma e spesso adorni di curiose ed interessanti illustrazioni, andò allora pubblicando su Riviste illustrate e giornali quotidiani e settimanali. Così egli si andava addestrando nello scrivere e preparando a lavori di maggior lena che dovevano ben presto dimostrare di che ricca e varia cultura egli fosse già fornito nonostante la giovanissima età e di quanto gusto artistico e letterario fosse dotato il suo stile. Un soggiorno a Capri, negli anni 1911 e 1912, fruttò una bella monografia pubblicata nel 1913 nella Collezione diretta da Corrado Ricci “L’ Italia Artistica”, presso l'Istituto di Arti grafiche di Bergamo, col titolo “L’Isola di Capri”,che Croce qualifica “una delle migliori della raccolta, accurata nella trama dei fatti, sennata nei giudizi, scritta con bel garbo letterario, che comprova le felici attitudini artistiche del suo ingegno”. E un anno dopo, nel 1914, usciva pei tipi dell’Editore Sandron di Palermo un’altra monografia di carattere storico su un argomento al quale egli aveva atteso vari anni raccogliendo notizie, documenti, illustrazioni e consultando quasi tutti i volumi pubblicati al riguardo: “Il Conte di Cagliostro nella storia e nella leggenda”. Anche a proposito di questo lavoro il Croce benevolmente così si esprime: "Respingendo tutte le apologie di recente tentate dal Cagliostro, che si sforzano di purgarlo delle frodi e degli imbrogli che commise, e lo lodavano sapiente ed umanitario promotore della massoneria, Petraccone acutamente giudicava che ciò che leva sopra del comune la figura del Cagliostro è l'energia della volontà, l'arte del dominare, e un certo indomito istinto rivoluzionario onde egli appare affatto diverso dall’altro celebre avventuriero, a cui malamente si vuole accostarlo, il Casanova, e non indegno dell’interessamento che per lui provò Volfango Goethe”.
Intanto, però, le attitudini di Enzo Petraccone si erano andate chiarendo e specificando e il suo spirito fino allora incerto sulla scelta degli studi finì coll’orientarsi verso quelli delle arti figurative. Conobbe allora artisti quali Edoardo Dalbono e Francesco Galante che lo ebbero entrambi carissimo ed il Galante ebbe a rendere un omaggio delicato all’amico perduto con un bel ritratto. Visitò pure in quel tempo le principali città italiane, ed i più importanti musei, soggiornando alcuni mesi a Roma e a Firenze; nella primavera del 1914 si recò anche a Parigi ove visitò diligentemente i due grandi musei del Louvre e del Lussemburgo e si rese conto delle tendenze dell’arte contemporanea. Conobbe letterati e critici d’arte e con molti rimase legato da amicizia come dimostrò il largo e sincero rimpianto dopo la sua morte.
In quello stesso anno 1914, l'Accademia Pontaniana di Napoli bandiva un concorso sul tema: “Luca Giordano, la sua vita e la sua arte” e il Petraccone dopo aver raccolto una grande quantità di materiale erudito e di fotografie, dopo essersi reso conto, nelle varie città italiane, della numerosissima produzione del Giordano, nei mesi della neutralità italiana, mentre era già in servizio militare, preparò e scrisse rapidamente una monografia sul pittore napoletano, che più tardi, mentre era già in guerra, fu premiata dall’Accademia, su relazione del conte Antonio Filangieri di Candida, insegnante di storia dell’arte nell’Università di Napoli. Quest’ultimo lavoro pubblicato postumo a cura di Benedetto Croce ebbe l'onore di molte recensioni italiane e straniere, tutte assai benevoli e nelle quali la perdita del Petraccone era lamentata come un vero danno per gli studi di storia dell’arte, che avrebbero avuto in lui un cultore pieno di gusto e di preparazione. Lionello Venturi fu un altro amico di Petraccone, che ebbe a rimpiangerne la fine immatura su “L’Arte”di Adolfo Venturi e sul “ Giornale Storico della Letteratura Italiana”. Ecco quanto scrisse su quest’ultimo periodico: “È una monografia scritta con amore, studiata a fondo. Per la vita di Luca Giordano, Petraccone ha risolto la questione dell’attendibilità del De Dominici come storiografo dell’arte del Seicento, accettandone i dati con prudente riserbo. Ha composto un quadro dell'attività pittorica napoletana del Seicento, profittando di studi recenti con un risultato più completo di quello ottenuto sinora. Ha poi seguito passo passo, cronologicamente, l’attività del suo pittore dimostrando una rara sensibilità nel sapere scegliere il motivo essenziale atto a interpretare ogni singola opera. Ma la maggiore attenzione dello scrittore e rivolta al giudizio sul “valore storico e lirico” dell'arte di Luca Giordano. Come non è possibile fare della critica che si rida della storia, non è nemmeno possibile fare della storia di aride date e di secche biografie. Ma come la storia, intesa quale studio del progresso delle forme artistiche, viene implicitamente a esaurire criticamente l'opera d’arte, così essa rappresenta, in certa guisa, la fusione organica delle due tendenze estetica e storica,,. E però con la propria esperienza critica, sorretta da quella del Croce e di altri, Petraccone giunge a scernere l'arte di Luca Giordano pur tra molte scorie. La portentosa facilità di assimilazione, l'inarrivabile ostentazione di abilità, i caratteri, cioè, sinora disprezzati o esaltati a seconda del gusto dei tempi, sono giustamente interpretati come semplici qualità commerciali. Pure, al di là di tale convulsa attività pratica, egli ritrova i momenti in cui, non più schiavo della sua mano, improvvisando per riposo un disegno o un abbozzo, il pittore libera la sua sensibilità e la sua fantasia, e concreta una visione di vita pittorica. Il Giordano minore diviene così il Giordano massimo. Onde l'appellativo di “ fa presto” non è soltanto più la notazione di un fatto, ma una condizione necessaria al Giordano per risolvere sulla realtà della creazione la sua vena pittorica, la sua instabile fantasia. In tal modo, ricostruzione storica della personalità e senso d’arte si fondono perfettamente in un giudizio che, per quanto può dirsi di cosa umana, appare definitivo".
Nel bel mezzo di questa attività e di questo fervore di studi di Enzo Petraccone, scoppiò l'immane conflitto europeo. Petraccone che aveva ritardato per ragioni di studio il servizio militare, si iscrisse a un corso di allievi ufficiali nell’Arma di artiglieria presso il 24° reggimento di Napoli, donde uscì sottotenente proprio pochi giorni prima della dichiarazione di guerra all’Austria. Fu mandato a raggiungere il 16° reggimento di artiglieria a Brescia che, quasi immediatamente dopo il suo arrivo, fu dislocato, in attesa della dichiarazione di guerra, verso il confine.
Da allora per tre anni, fino al fatale 15 giugno del 1918, egli fece silenziosamente, senza mai lagnarsi, il suo dovere, con le sole interruzioni delle licenze annuali. Nell’estate del 1917 trovando troppo monotono il tranquillo settore delle Giudicarie dove si trovava, fece domanda per essere ammesso alla scuola dei Bombardieri in Susegana, e di là, appena nominato tenente di detta arma, fu mandato nel settore del Carso. Dopo alcuni mesi fu destinato sull’altipiano di Asiago in una posizione assai pericolosa, senza che mai si alterasse la calma filosofica con cui egli prendeva quegli avvenimenti dalla cui fatalità si sentiva come dominato, e poi fu mandato per un breve periodo di riposo a Vicenza. Si trovava in questa città quando a un tratto alla vigilia della battaglia del giugno 1918 ebbe ordine di raggiungere con la sua batteria il monte Valbella, posto difficilissimo, ove la mattina del 15 giugno soccombeva dopo aver combattuto eroicamente. Non è il caso di rievocare la circostanza della sua morte che fu conosciuta solo più tardi, essendo dal Comando stato dato come disperso, e neppure ricordare le ansie di vari mesi di speranze, seguite da una terribile disillusione.
Fu proprio durante gli anni di guerra egli ebbe ancora occasione di scrivere i “Colloqui col cane Tell”, il cui manoscritto egli mandò proprio a Benedetto Croce a mezzo di un suo commilitone, e che furono pubblicati postumi in appendice al “ Luca Giordano”. Informati a un profondo scetticismo essi formano uno strano contrasto con la vita nobile e laboriosa e la morte gloriosa di Enzo Petraccone. “Coloro che li leggeranno - scrive Benedetto Croce - saranno colpiti dall’amara tristezza che li compenetra, dall’aperta professione che vi si fa di scetticismo e di pessimismo, dalla sfiducia che si manifesta su quelli che si chiamano gl’ideali, dal disamore per la vita in sé stessa. Lo scrittore indirizza il pensiero e la parola a un cane che gli fu a lungo compagno nei presidii montani e nelle trincee; e con quella finzione intende significare che egli non trova nella vita degli uomini maggior pregio che in quella di un qualsiasi animale, la quale paragonata alla umana sembra più schietta e più logica, com’è forse più felice. Scritti in guerra, da un ufficiale che faceva la guerra combattuta, sull’altipiano di Asiago, la guerra vi è appena menzionata e solamente quasi a sfondo di paesaggio: composti nella maggior parte tra la fine deI 1917 e i primi del 1918, non vi é traccia degli avvenimenti di quei giorni, né di travaglio e passione per la patria che non vi è mai nominata,,. Come si spiega questo contrasto tra il pensiero informato a scetticismo e l’azione così nobile e alta? Il Croce risponde a questa naturale domanda, dicendo che i Colloqui erano niente altro che brama di luce, bisogno di sincerità rigorosa, autocritica di un’anima nobile che non era riuscita ancora, sebbene vi si sforzasse, a dominare con la mente il mistero delle cose; erano l'anelito religioso di chi cercava e non trovava ancora il suo Dio, il Dio che pur viveva nel suo petto e che ispirava e guidava tutto il suo sentire e tutte le sue azioni. Ed il Brognoligo, che anch’egli si poneva la stessa domanda, dopo aver lodata “ la bellezza letteraria dei Colloqui, la sobrietà efficace della frase e la serenità che li governa, l'una e l'altra proprie di chi, quasi straviandosene, è riuscito a dominare il proprio pensiero, e che ne fanno una delle migliori opere suscitate dalla guerra, osservava acutamente che il contrasto si può spiegare “con quella squisita delicatezza per cui certe anime hanno una specie di pudore dei loro buoni sentimenti come delle loro forze intellettuali; non se ne vantano anzi non ne parlano mai, paghi di mostrare gli uni e le altre coi fatti, paurosi che questi non siano quali vorrebbero, schivi sopra ogni cosa di far parlare di sé, parlano e non sembrano abbiano doti che giustifichino quel parlare: anime profonde e ardenti, ma timide e chiuse, lavorano in silenzio e si rivelano solo in qualche occasione”. Così il paragone tra Enzo Petraccone e Luigi La Vista, accennato da più persone, che ebbero a scrivere di Lui, tra cui il Marone e Concetto Valente, tenuto conto delle differenze delle epoche, può bene rendere il concetto di una simiglianza di idealità in due giovani cui tanto luminoso avvenire nella carriera delle lettere splendeva dinanzi. Ed il paragone può essere proseguito nel caldo elogio che del Petraccone ha fatto il suo maestro Benedetto Croce, così come del La Vista fece Francesco De Sanctis.
Opere di Enzo Petraccone
Volumi:
1° L’ Isola di Capri —. con 130 illustrazioni — Istituto Italiano d’Arti Grafiche — Editore — Bergamo 1913.
2° Cagliostro nella storia e nella leggenda — Remo Sandron —Editore — Palermo 1914.
3° Luca Giordano — opera postuma — aggiunti “ I colloqui,, a cura di B. Croce — Riccardo Ricciardi — Editore — Napoli 1919.
4° La Commedia dell’Arte — Storia — Tecnica — Scenari —a cura del dott. Nicola Nicolini — opera postuma — Riccardo Ricciardi Editore — Napoli 1927.
Articoli più rilevanti
1° Un aeronauta italiano del ‘700 — in “Secolo XX” — Anno 1910 — pag. 580.
2° Dieci anni di vita letteraria (a Roma dall’ 80 al ‘90) in “Secolo XX” Anno 1910 — pag. 650.
3° Il poeta dell’ anima napoletana Salvatore di Giacomo — in “Secolo XX” — Anno 1901 pag. 789.
4° Maria Carolina e Napoleone — in “Giornale d’Italia” — del 21 agosto 1911 — n. 232.
5° Cortesie italo-turche verso la metà del ‘700 — in “ Giornale d’Italia” del 25 dicembre 1911 — n. 358.
6° I sommi interpreti dell'anima napoletana: Edoardo Dalbona e Salvatore di Giacomo — in “Noi e il Mondo” Anno 1912 —pag. 150.
7° Benedetto Croce — in “Noi e il Mondo” Anno 1914 — pag. 430.
8° Matilde Serao — in “ Giornale d’ Italia” del 6 giugno 1912.
9° Matilde Serao e “O Giovannino o la morte” , — in “ Orfeo” del 9 novembre 1912.
10° La moglie di Cagliostro — in “Secolo XX” del 1911 — p.619.
11° Posillipo nell’antichità — in “ Corriere del Vomero e di Posillipo” del 23 marzo 1913.
12° La Scuola di Posillipo — in “Corriere del Vomero e di Posillipo” dal 30 marzo 1913.
13° Artisti stranieri a Capri — in “ Italia” del 1913 — pag. 265.
14° Il Capitan Trabucco — in “ Giornale d’Italia” del 16 marzo 1913.
15° Un artista d’ eccezione: Diefembach — in Emporium 1913.
Su Petraccone vedi
1.La bella prefazione del suo maestro ed amico Benedetto Croce al Luca Giordano, in cui si riassume la vita e si tratta delle sue opere.
2.Il discorso tenuto da Benedetto Croce in Muro Lucano il 12 giugno 1923 inaugurandosi la “Biblioteca Enzo Petraccone” pubblicato in Conferenze e Prolusioni del 10 agosto 1923 anno XVI n. 15.
3.Gioacchino Brognoligo - Lo scetticismo di un Caduto per la Patria - in “ Sulla corrente” del 15 gennaio 1920 anno I fasc. I.
4. Alberto Buonoconto - A proposito di Luca Giordano- in “Giornale della Sera” di Napoli dal 21-22 agosto 1919.
5. Gherardo Marone - Un maestro e il suo discepolo - in “ Il Mezzogiorno” del 7 luglio 1919.
6. Armando Pappalardo - Luca Faprasto in “Giorno” del 12-13 luglio 1919.
7. Lionello Venturi - Ampia recensione del Luca Giordano del P. in L’ Arte di Adolfo Venturi - Anno 1920 pag. 92.
8. Lionello Venturi - Recensione del Luca Giordano in Giornale Storico della Letteratura italiana del 1920.
9. The Athenaeum - del 24 ottobre 1919. Un giovane critico italiano - Recensione del Luca Giordano.
10. Der Cicerone del luglio 1921 - Recensione del Luca Giordano - pag. 406.
11. Concetto Valente - Pagine su 1’Italia meridionale in “ Resto del Carlino della Sera” di Bologna del 25 aprile 1923.
12. A. Martuscelli - L'anelito religioso di uno scrittore morto per la Patria - in “Giornale d’Italia” del 28 giugno 1922.
13. G. Brognoligo in Fanfulla della Domenica del 10 dicembre 1918 - n. 24.
14. Concetto Valente - Le città morte dell’Ionio, Zanichelli ed. Bologna - pag. 104,
15. Giovanni Petraccone - "Enzo Petraccone" - su La Basilicata nel Mondo 1924-1927.
Uno scritto inediito di Enzo Petraccone c’è su "La Basilicata nel Mondo” - 1924-1927"
“Macchiette e pupazzetti dal fronte” di Enzo Petraccone
“Ho scoperto tempo fa un pupazzettista. È caporale nella Fanteria: si chiama Gigi Brondi, è alunno dell’Accademia di Brera e ha diciott’anni. Alto, magro, con un viso mobile e intelligente, Gigi Brondi non è uno di quei tipi di soldati rumorosi che spandono dappertutto il loro buon umore e l'allegria: è un tipo chiuso, modesto ma non triste ed eccessivamente pensieroso. Egli vede tutto quel che gli accade intorno attraverso la sua sottile vena umoristica, fine e non sguaiata, malinconica e non mordace e segna tutto quel che lo colpisce in certi suoi album della guèrra che sono un po’ il suo diario.
Nelle ore di riposo egli si ritira in un angolo e circondato da pochi fidi amici che seguono con occhio curioso e meravigliato il rapido succedersi dei tratti della sua matita sulla carta, scrive le sue impressioni, annota i suoi commenti délla giornata. Quando l'ho scoperto, o per dir meglio, quando mi si è scoperto, mostrandomi un mio riuscitissimo pupazzetto, ho pensato subito al profitto che se ne poteva trarre e ho pensato subito a “Noi e il Mondo", e a Lucio D’Ambra. Ma sarà ancora a Roma — mi sono poi domandato — e detterà ancora Lucio D’Ambra (novello Petronio della Rivista mensile) dall’elegante redazione di via Milano le sue raffinate leggi dell’eleganza tipografica? E nella speranza che la guerra non abbia ancora strappato Lucio D’Ambra alle abitudini e all’affetto del suo pubblico di lettori, un po’ pregando, un po’ valendomi dell’autorità del grado, ho fatto man bassa del libro dei ricordi di Gigi Brondi di cui presento una parte con qualche brevissimo commento.
I pupazzetti del nostro artista caporale sono però quasi tutti estivi: il freddo e la neve, egli ha dichiarato, si prestano poco alla caricatura e, in genere, alle arti figurative per svariate ragioni che sarebbe troppo lungo esporre ma di cui due principalissime son queste. Io: il freddo permette poco la libera esplicazione del movimento del ritrattabile, cioè del soldato; la neve rende tanto monotono il paesaggio che è possibile e facile esaurirlo in un disegno che ricordi assai da vicino il famoso quadro del passaggio degli Ebrei attraverso il Mar Rosso, in cui, come certo tutti ricordano, l'artista aveva ritratto il suo soggetto proprio nel momento (vedete caso curioso!) in cui il Mar Rosso si era ritirato e gli Ebrei erano già passati.
Contentiamoci perciò di spigolature d’altri tempi aspettando che le rondini ci annunzino la primavera e che sui monti rinverdiscano le zolle. Poiché come ben dice Gigi Brondi, la guerra moderna è fatta dalla zolla, questa cosa modesta e disprezzata invocata per lo passato solo dagli scrittori sodalisti di provincia, questo umile quadratino di terra che offre invece tutto sé stesso con abnegazione e meraviglioso spirito di sacrificio e protegge il soldato che combatte dalla trincea e serve di scudo contro la pallottola insidiosa e contro le schegge che vi si affondano senza che essa levi un solo lamento. Con le zolle si fa tutto: trasportate comodamente in portantina, accomodate, ritagliate, squadrate, le zolle servono a tutto, alle opere puramente guerresche come a quelle, starei per dire, voluttuarie.
Con che cosa si costruisce un appostamento per mitragliatrice? Con le zolle!
Con che cosa si costruisce una cucina dà campo? Con le zolle!
Dopo la zolla, il badile e il piccone sono due dei principali fattori della grande trasformazione dei sistemi guerreschi: essi scavano le trincee, tagliano le vie sulle montagne inaccessibili, frugano e sconvolgono la terra adattandola alle diverse esigenze della guerra, spezzano la roccia, tagliano le amiche zolle, preparano il terreno al principe della trincea: il paletto da reticolato.
Figlio del tronco d’albero, il solido e pesante protettore delle ridotte e delle trincee blindate, il paletto agile, tenace, svelto, robusto, è il più forte protettore, come il più poderoso nemico nella guerra dei nostri giorni. O che protegga una linea di difesa, o che stia lì pronto a sbarrare una strada, un reticolato, infatti è quasi più terribile del fucile, del cannone, della bomba.
Dopo il lavoro, il riposo. Nelle seconde linee specialmente c’è, ed è naturale che ci sia, più calma, più tranquillità, una più varia e meno preoccupante attività. Dove ora non è che un vasto e desolante lenzuolo di neve, alcuni mesi or sono era ancora un profumato tappeto di fieno secco tra cui s’affacciava timido il tardivo fiore della montagna: il soldato vi dormiva al sole i suoi sonni tranquilli e quando echeggiava per l'aria il tanto atteso grido de la posta ed avveniva la distribuzione della desiderata corrispondenza (ore felici passate rileggendo venti volte la stessa cartolina!) correva a sedervisi per procedere alla prima lettura delle numerose pagine della lettera ricevuta e vi si adagiava per attaccare l'articolo di fondo del giornale sulla politica estera.
Intorno il paesaggio trasformato dall’opera assidua e instancabile: un posto di medicazione dietro un trincerone e le vie d’accesso coperte serpeggianti sulla montagna, dietro cui il sole va scomparendo.
Qualcuno guarda immelanconito: qualche altro pensoso indugia davanti alla fumante gavetta, qualche altro ancora scribacchia già colla matita la risposta alla lettera ora ricevuta; il soldato barbiere attacca la testa di un paziente collega. Il capitano guarda anche lui e segue con l’occhio il tramonto che va velando d’ombre il terreno e quasi accarezza, guardandole, quelle immagini famigliari di soldati ch’egli conosce uno per uno. Il cielo intanto diventa oscuro: poi d’improvviso comincia un grandinar di goccioloni grossi e radi che s’abbattono violenti sulla campagna. Passa il Colonnello.
E mentre il barbuto soldato pensa alla sua casetta di campagna e alla sua donna che l’aspetta, la mente, chi sa perché? si volge compiaciuta verso l'immagine di una comoda poltrona in cui sprofondarsi fumando, immersi nella lettura di un giornale che parli degli ultimi rivolgimenti della Cina. Ma poi si levano gli occhi, si guarda di là oltre le montagne che chiudono l’orizzonte e ci si sente pronti e sicuri".
Alla sua memoria fu intitolata la Biblioteca di Muro Lucano, inaugurata da Benedetto Croce che nella cerimonia disse: “In quel giovane, - consentite che ciò attesti chi lo ebbe per più anni accanto a sé e sentirebbe di mancare di riverenza ad una tomba se non attestasse il vero - in quel giovane niente era di volgare: non cupidigie, non vanità, non brama di spingersi innanzi e di mettersi in mostra. Una naturale dignità, non disgiunta da garbo e grazia, e velata ma non turbata da malinconia, si manifestava in tutti i suoi atti e nelle sue parole.”
A Petraccone sono state intitolate strade a Muro Lucano, Napoli e Milano.
10) Manlio PINTAURA - “Roma" di Napoli
Nato il 20 agosto 1894 a Napoli. Figlio di Corrado. Sottotenente di complemento del 12° reggimento fanteria della Brigata Casale. Morto il 10 giugno 1915 a Lucinico, frazione di Gorizia, nell’Ospedaletto da campo n. 44 a seguito delle gravi ferite riportate in combattimento. Redattore de “Il Roma” e socio dell’Unione giornalisti napoletani. |