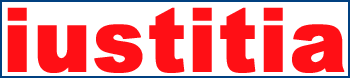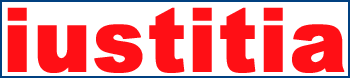Giorni fa, verso mezzanotte, un’ora che congeda i pensieri più assillanti e comincia a meglio disporsi al sonno, dopo averlo cercato e anche “assecondato” con palinsesti televisivi da sbadigli, una telefonata inattesa ridesta in me tanti ricordi, da rimanere poi sveglio alla maniera di un grillo confuso dal buio avanzato. È una di quelle telefonate, che appena ne senti l’inizio, lento, misurato, già presago di qualcosa di serio da comunicarti, crea un senso di ansietà e molto altro ancora, facendoti riflettere su come uno stato d’animo possa mutarsi, all’improvviso, dalla tranquillità in ben altro e di più inquieto. A telefonarmi è un caro, bravo collega, giovanissimo ai tempi in cui lasciai “Il Mattino”, che chiamerò Gigi per discrezione. Di primo acchito non lo riconosco, anche per il suo timbro di voce ora più compassato, il quale mi dice: “Pronto, sono Gigi!”. “Chi?” replico. E lui più deciso: “Ma come non ti ricordi di me? Sono Gigi”, e mi scandisce nome e cognome. “Oh, scusami – ribatto – non ti sento da molto tempo. Comunque quale buona nuova mi porti?”. “Quanto vorrei fosse come dici tu- mi fa Gigi e precisa- ma non posso. Anzi ti dico subito che è una brutta notizia: tra pochi mesi, a settembre, il nostro giornale lascerà via Chiatamone, andrà in uno di grattacieli del Centro Direzionale”. “Dove? Centro Direzionale di che? Ma questa è una cattiveria- gli rispondo incredulo e aggiungo- No, non posso credere che finirà in quel deserto di stagnante modernità, da coprifuoco? E lui di rincalzo: “Si hai detto bene, deserto. Anni fa, quando voi siete andati via, nell’ultima assemblea di redazione dei congedi e dei saluti, sin da allora avete detto che sarebbe finita così. E così finirà. Ce l‘ha comunicato l’Editore. Tutto è avvenuto all’improvviso. Ora l’unico conforto ci può venire solo da colleghi, come te, che non hanno mai finito di amare questi luoghi”. E conclude: “A presto!”
Preso da un’amarezza greve, pesante, che scaccia ogni accenno di sonno e di stanchezza, reagisco con la raccolta di nobili ricordi. Notizie del genere fanno molto male perché toccano il cuore. Raffaele La Capria, dal cuore grande e instancabile, in uno dei suoi formidabili pezzi, e quale non lo è, ricorda: “Con il cuore non si scherza. È un muscolo che pulsa e pompa emozioni. L’esistenza si affronta con il cuore. È questo il prodigio dell’universo, è li dentro la formula misteriosa che svela la vita”. Si spiegano così le emozioni che cominciano a scorrermi dentro con una intensità molto simile a quelle piccole fonti sorgive primaverili, nutrite di inesauribili “pollentine”. All’improvviso, dalla mia casa, dal mio piccolo studio guardo verso Palazzo Sessa in via Cappella Vecchia, cuore, alla fine del ‘700, del Salotto di Monsignor Capecelatro, dove Stendhal, Canova, Francesco Mario Berio, Rossini, tanti grandi artisti accorrevano da tutto il mondo per incontrare Napoli capitale, la sua gaiezza e il suo estro, e la notizia del giornale che “trasloca” mi suona sempre di più come un’offesa alla civiltà di questa città, da collocarla nel novero dei torti più crudeli. Questo non è un trasloco, è uno sfratto. Le immagini sfocate della notte, le luci più opache, le parole prive di forza nel farsi ascoltare, mi lasciano ancora più avvertire questa ferita dell’animo. Da tempo non vado al giornale, ormai divenuto un bunker di tecnologie avanzate e disumane che hanno fatto inabissare in processi e codici irripetibili uno dei lavori più belli al mondo, cancellando scenari da mito. Stanotte ho solo una voglia incontenibile: correre in via Chiatamone 65, trecento metri da casa mia, piantarmi davanti alla palazzina del giornale e urlare, urlare, portando le mani alle tempie come quel fantasma del celebre quadro di Edvard Munch, urlare ancora al cielo del lungomare e poi dentro al dirimpettaio tunnel, deserto a quest’ora: “Maledetti! Maledetti! Non si sradica un grande albero dalla sua terra. È un atto inqualificabile. Punibile con la pena più atroce della ignominia, del disprezzo. Il giornale è un immenso, sacro albero genealogico, sui cui rami sono sempre vivi i nomi di giornalisti, maestranze, artisti, di gente che vi hanno lavorato e si sono donati con una passione indomabile, senza risparmio. Deve stare nel cuore della città, che, ogni alba, appena desta si è sempre chiesta: “Ma ‘O Matino che dice?” Un giornale non può vivere fuori da questo grembo, a maggior ragione di una città particolare, che ogni giorno ispira tante pagine con la sua vita travolgente, fastosa e disperata, nobile e “lazzara”. Non a caso un vecchio, felice slogan di via Chiatamone diceva: “Caffè in tazza, Il Mattino in piazza”. Come faranno un giorno a giungere lassù, su un grattacielo, l’odore d’inchiostro, le concitate suppliche di un popolo unico, abituato al vitale intrico dei vicoli in un permanente presepe vivente, i caffè sospesi del mitico bar di “Martino”?
La memoria, gelata dalle parole di Gigi, ora comincia a sciogliersi sempre più e mi riporta a quando ero bambino, al ricordo del postino del mio paese, Saverio, carattere divertente e burlone, che, all’alba, appena arrivavano i giornali con la prima corriera blu, provvedeva a portare una copia a mio padre, come se gli porgesse un vassoio di sfogliate calde, talmente sentiva la vitale fragranza di quel foglio. La consegna era tassativa: un giorno “Il Mattino” e l’altro successivo il “Roma”. Un’alternanza mai disattesa di due giornali, che il futuro mi ha poi riservato e, in cui, ho lavorato con la passione, l’impegno e la curiosità di un eterno novizio. Mio padre li apriva con un desiderio predominante di trovarvi sempre un articolo di un suo illustre conterraneo, di Chiusano San Domenico, allora condirettore del “Mattino” e figura mitica del giornalismo napoletano: il grandissimo Don Carlo Nazzaro, un irpino- napoletano con un gigantesco “Don”.
La mia prima casa fu il “Roma”, giornale postunitario di guerriglia, nato nel 1862 per la tenace volontà di due garibaldini, che non si limitarono a festeggiare la caduta del Regno di Napoli ma continuarono le loro battaglie per sostenere, come potevano, il completamento della unificazione, avvenuta poi con la breccia di Porta Pia e la fine del Papa Re. A me toccò la fortuna di lavorarvi verso la metà degli anni Sessanta in poi, ai tempi di un direttore, imbattibile polemista, Alberto Giovannini - donne, giornali e cavalli - che coniò un titolo, molto audace e tra i più citati sul trasformismo di sette consiglieri comunali napoletani, passati dal Partito Monarchico alla Dc, definiti i “sette puttani”. Poi venne “il Mattino”, vi approdai a fine luglio del 1987, attraversando a piedi per una scelta ostinata e convinta, il tunnel della Vittoria: da via Acton, tratto terminale di via Marittima, dove c’era il mio vecchio giornale - il “Roma” chiuso anni prima da una criminale rappresaglia di palazzo, a via Chiatamone - davanti al “Mattino”. Questo tunnel rappresentava la metafora più verace della mia lunga traversata professionale mentre mi accasavo felicemente sotto la testata, più prestigiosa del Sud, su cui brilla e svetta il “re dell’alba”, uno stupendo gallo dalla cresta fiera e i bargigli poderosi, che solo a vederlo, dispone alla “bella giornata”, operosa e solerte. Ricordo la prima notte di lavoro, le parole amiche del Direttore Pasquale Nonno, che passò sul tardi in redazione dopo un torneo di scopone, di cui era un imbattibile giocatore, la cordialità di tanti colleghi ai vertici del Mattino. La redazione era molto numerosa tra giornalisti, amministrativi, tipografi, dimafonisti, stenografi, rotativisti: una “cittadella di laboriosità e di vocazioni”, avrebbe detto Benedetto Croce, dove era impossibile annoiarsi e ovunque si sentiva una imperante fierezza, che discendeva dalla coppia leggendaria, Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao, sposi nella vita e soci fondatori, del “Mattino” in piazza dal 16 marzo del 1892. Gli articoli di Scarfoglio affondavano i governi: uno sul matrimonio di Vittorio Emanuele III con la principessa Elena di Montenegro mandò su tutte le furie casa Savoia per il titolo: “Nozze coi fichi secchi”, che mirava a definire la portata dell’evento, troppo deludente, rispetto alle attese. La risata grossa della Serao invece faceva vibrare i salotti di Napoli. Donna Matilde quando scriveva, esponeva il tricolore sul balcone e lo ritraeva appena congedava il pezzo. Gli anni della fondazione si collocano nel pieno fervore post unitario della fiorente nascita di molti giornali, finalizzata a proteggere gli interessi di una borghesia emergente e di un capitalismo giudizioso. La culla del giornale era a Vico Rotto San Carlo, oggi piazzetta Matilde Serao, dietro alla Galleria, a pochi passi da via Toledo. Si entrava da una scaletta stretta, buia, sdrucciolevole. Nello stesso edificio c’erano due case d’appuntamento. Quel tipo di vicinato non aveva mai dato fastidio al direttore Giovanni Ansaldo. Per Carlo Nazzaro era “Napoli con le sue miserie e le sue nobiltà”. Quando i due uscivano, le “donnine” li salutavano per le scale con riguardo: “Buona sera direttori”. Ma non si sognarono mai di dirgli: “Accomodatevi”. Poi, dopo circa un secolo, il primo maggio del 1962, finì, si può dire, la lunghissima e scintillante “Belle Époque” de “Il Mattino”, che passò dalla Galleria a via Chiatamone, 65.
Ero stato qui, altre volte, in visita ad amici, ma erano stati fugaci atti di cortesia. Ora tutto era così diverso. A rendermi subito il giornale molto caro, fu l’intima percezione di sentirmi un redattore già dentro una vivace e orgogliosa comunità, ravvivata già all’ingresso del giornale nella “prestanza” di un cimelio storico, una Linotype, a me molto familiare, in mostra in una nicchia della “Hall”, dai tempi in cui ero stato correttore di bozze al “Roma”. Era l’ultimo esemplare dell’età del piombo, con una caldera, dove un moderno dio Vulcano si divertiva a fondere e poi a ricomporre righe e pensieri. Il vento glaciale dell’alta tecnologia aveva da poco spazzato via questi cimeli ma alcuni versetti di tenera nostalgia posti su una targhetta della Linotype mi indicarono lo snodo epocale, tra un prima e un dopo, di cui ero testimone. La poesia del linotipista Salvatore Di Meglio: ‘O chiummo ca se ne va”, è l’epitaffio più accorato di un’epoca: ma quanti, in futuro, potranno ancora continuarlo a leggere? …” Pe’ tant’anne t’aggio rattato/, allisciato, accarezzato, e abbuzzato”.
Scriveva Carlo Nazzaro, i cui elzeviri incantavano il monumentale Ansaldo: “Mando venti righe alla linotype e ritornano come fiori da un prato. La linotype è una ispiratrice. Le parole che tornano dalla linotype sono passate per il fuoco. Venti righe escono dalla penna come scolarette anemiche e ritornano da Vispe Terese. L’elettronica, la cibernetica, la computisteria chi sa quali rivoluzioni porteranno nel nostro mestiere…” Chi sa, Chi sa? Se lo chiedeva già negli anni Sessanta con pensieri di garbata preoccupazione per un progresso, “evanescente non troppo governato e anche disumano”. Don Carlo aveva, già allora, ragione di temerlo. Lo abbiano verificato. Nei giornali non ci sono più il calore del piombo, la felice caciara notturna dei giornalisti a lavoro: una umanità travolgente e creativa che veniva su dalla gavetta. “Il progresso non si respinge, si disciplina”, diceva un sindacalista. Peccato che la disciplina abbia portato a scelte diaboliche: popolando i giornali di cervelloni e cacciando i cervelli. Mentre le cicliche crisi editoriali hanno scaricato i deficit sulla comunità e caricato i profitti su altri conti.
La struttura interna dell’edificio di via Chiatamone 65, alle spalle del lungomare Partenope, risale al 1887. Il progetto originario ottocentesco nacque da un’ariosa visione edilizia, mutuata da un’idea del ritrattista inglese Robert Baker, sostenitore della necessità che ogni edificio dovesse poter godere di un panorama di ampio respiro. Di qui il nome di “Panorama” allo stabile, oggetto di continue trasformazioni, prima nei Grandi Magazzini Miccio, poi addirittura di Circo del Varietà e ancora di “Teatro Verdi”, fino a sede definitiva (purtroppo non più) del “Mattino”, in una palazzina neorinascimentale. Che riflette il singolare impianto, diciamo pure, diviso in “gironi”, sapientemente distribuiti in vari piani per l’amministrazione, la redazione, la tipografia e rotativa; dal 1994, però, sempre più disabitati per una crescente strategia di tagli e prepensionamenti. La preparazione di un giornale sa molto del teatro, dove ognuno recita a soggetto, porta il proprio contributo di idee, per poi sintonizzarsi con le decisioni, le scelte definitive del regista, del direttore, che molto spesso sta sul podio come i grandi maestri d’orchestra, pronti a bacchettare gli orchestrali con uno sguardo. Quando intorno alle undici si alza il sipario, la prima riunione preparatoria è di solito presieduta dal direttore, cui siedono accanto il redattore capo e in cerchio i responsabili dei vari settori Politica, Cronache nazionali e locali, Economia, Sport e Spettacoli. È una narrazione corale che si offre poi, ogni giorno, ai lettori, alla città. Giovanni Ansaldo difficilmente scendeva in cambusa, nella cucina del giornale, lo sentiva come un dovere non farlo, pensando che sarebbe stato più d’intralcio che di giovamento; mentre bastavano solo poche righe di un suo commento su un fatto di attualità per far schizzare in alto il gradimento del giornale e, quindi, le copie vendute. La sua indipendenza conteneva un fiero avvertimento: “Chi mi chiama alla direzione di un giornale, deve fidarsi di me, non può lusingarsi di avermi pronto con la penna in mano ad ogni telefonata”. Pasquale Nonno, invece, dimorava nei “palazzi”, intuendone e spesso anche sventandone le manovre con articoli spiazzanti: nessuno come lui sapeva spiegare il più intricato snodo politico. “Ai tempi di Tangentopoli- gli piaceva ricordare- non sono stato mai per la gogna: lo rivendico con l’orgoglio per una città come Napoli che respinse l’Inquisizione anche contro la volontà dei più potenti padroni: i Viceré”. Nonno ereditò un giornale in buona salute che, grazie anche alle imprese di Maradona, portò a vendere 180 mila copie. Indimenticabile, invece, il breve interregno di Sergio Zavoli, un “astro” del giornalismo, che oggi vive da imperatore in una villa di Monte Porzio Catone guardando dall’alto Roma capitale. Le riunioni di redazione, sotto il suo consolato, duravano più di un’ora, acquattato come un gattone sempre attento, con solenne e severa partecipazione, a cogliere cautamente negligenze o sciatterie con parole da catechismo laico. Lui non dirigeva, pontificava sulle nequizie della società e su tematiche struggenti, facendoci destare in mezzo mondo grandi firme, che, per la differenza dei fusi orari, spesso mostravano di volerci mandare a quel paese. Ma non lo fecero mai. Quei mesi, alla corte di Zavoli, mi furono di grande arricchimento nella redazione politica con Nacchettino Aurigemma, Gianni Festa, Lello Venezia: l’arena più rovente del giornale nella stagione di un maggioritario, rivelatosi subito, litigioso e ingovernabile.
Se Vico Rotto San Carlo è la culla del mito, via Chiatamone è la sua magica esaltazione, nell’aver saputo fondere in una narrazione unica la storia gloriosa del “Mattino “dai tempi di Edoardo Scarfoglio e di Matilde Serao. Per chi ha avuto il privilegio di lavorarci è stata questa la percezione primaria, trasmessa da una formidabile generazione di giornalisti, eredi degl’inestinguibili valori originari: Franz Guardascione, Riccardo Cassero, Orazio Mazzoni, Arturo Fratta, Gerardo Guerra, Mario Stefanile, Franco Grassi, Max Vairo, Giacomino Lombardi, Ernesto Tempesta, Romolo Acampora, Peppino Pacileo, Mario Caruso, Lello Greco, con apporti di ricordi e memorie di grati sentimenti virgiliani. E un inestinguibile profondo, senso di gratitudine e di ammirazione per il ricordo sempre vivo di un giovanissimo e coraggioso giornalista, Giancarlo Siani, che pagò con la vita la sua implacabile lotta all’Antistato, sentita come un dovere morale e civile.
Il Mattino e via Chiatamone avrebbero dovuto essere inseparabili, come lo sono e lo saranno il “Corriere della Sera” e via Solferino a Milano, “Il Messaggero” e via del Tritone a Roma, mai essere divisi neanche di fronte a un’offerta da favola. Ci sono luoghi in cui la storia s’appiglia, s’intreccia, s’avviluppa, diventa un tutt’uno. Cancellare la storia, farla sbiadire, è la più grande offesa alla civiltà dell’ex capitale, ma anche a una umanità di proverbiale dedizione al lavoro, che qui ha trascorso più tempo che in famiglia. File di nomi e di firme prestigiose, apparse su milioni di pagine per sostenere battaglie civili, sociali, diritti fondamentali, generazioni di geniali maestranze. Che ne sarà di un bene culturale fortemente amato dal popolo, da chi vi ha lavorato, una “cittadella delle vocazioni”, che ogni notte ci riservava emozioni rinnovate, appena il rumore sordo della rotativa ma intenso, preannunciava il dono simultaneo delle prime copie? Finirà, nel modo peggiore: dov’è passata tanta gloriosa storia ci saranno un garage e un grande Supermercato. Atterriscono il silenzio e l’ignavia delle istituzioni, che non hanno aperto bocca su questo sfratto: loro che la tengono sempre aperta per enfasi e ingordigia.
I giornali sono “un granaio” di aneddoti, un inesauribile vivaio di umanità: artisti, gente dello spettacolo, dello sport, insomma di personaggi più vari ed eclettici, che si ingegnano a rendere la vita meno complicata. È un circo che sta sempre fermo e prepara ogni giorno uno spettacolo sempre nuovo e imprevedibile. Una sera nella stanza di Giacomino Lombardi, redattore capo centrale, che si era dovuto momentaneamente allontanare, mi trovai a dover dirimere con Gianni Festa un incipit di “duello incendiario”, tra due grandi scrittori Mimì Rea e Luigi Compagnone. Che erano soliti sfogare le loro gelosie, appigliandosi ai giudizi più pretestuosi su Napoli. All’improvviso il primo disse all’altro: “Ritieniti schiaffeggiato”, e questi di rimando: “Anche tu, cristianamente, sulla guancia destra e sinistra”. Ma schiaffi in concreto non ne volarono mai: i due scrittori sapevano volersi bene così. Compagnone che gli sopravvisse, non perse mai occasione per ricordarlo, dicendo a chi sparava qualche grossolana bugia: “Ahi Ahi, questa, Mimì, non te l’avrebbe fatta passare liscia”. Mimì era come Bolano della satira di Orazio, una testa calda e balzana. Oggi fosse vivo, rubando versi ai feroci canti popolari del ’99, di fronte a questo iniquo sfratto, direbbe: “Mobilità, mobilità, mobilità / fatte cchiù ccà, fatte cchiù là, / cauce ‘nculo a la libertà”. |