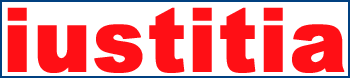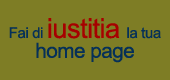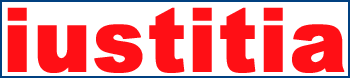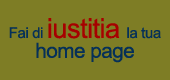Gentilissimo direttore,
per formazione e carattere “so di non sapere” (Socrate), per questo motivo m’immagino che quando altri presumono di svillaneggiare un collega imputandogli presunti svarioni al soldo delle sue incursioni nella storia patriottarda, sarebbe bene appassionarsi ad un approfondimento dei temi trattati che vada ben oltre un’articolessa, magari assaporata tra lasagne post carnascialesche e ragù “peppetiato” ad libitum nella domenica di festa e di lotta contro le presunte castronerie dei mass media campani. Se non altro per evitargli, se queste leccornie gli dovessero aver appesantito lo stomaco, una magrissima figura ex post. La querelle, almeno dal punto di vista del tuo giornale, è inopinata: Garibaldi non pronunciò “obbedisco” nell’incontro di Teano col sovrano piemontese, ma a Bezzecca da dove vergò e inviò al re un telegramma dopo un epilogo vittorioso, anche se minore, della campagna (terza guerra d’indipendenza) volta a spianare la strada per la conquista del Trentino, territorio dipendente dall’Impero austriaco, per favorirne così l’annessione al Regno d’Italia. L’ordine del generale La Marmora, per conto del sovrano, fu perentorio in vista di un armistizio con l’Austria assecondato dalle sonore sconfitte italiane di Custoza e Lissa. E Garibaldi obbedì.
Nel corsivo che mi tira in ballo, a firma del tuo collaboratore Oliviero Bertini, si ironizza: “Il 16 marzo, nel tg della sera, un servizio di Vincenzo Perone su Garibaldi, grondante gerundi e patriottismo, sferra la prima stoccata revisionista… “Siamo alla fantastoria”… “le camicie rosse di via Marconi hanno indossato l’elmo di Scipio al contrario e hanno cominciato a brancolare nel buio della Storia, senza neanche l’aiuto di un Bignami”. Forse al tuo esercito di “Francischiello” a caccia di improbabili sviste nella cassetta degli attrezzi dei colleghi, sarebbe bastata, come vedremo, un po’ di conoscenza dei fatti storici non sfogliati sui quarti di copertina per non essere costretti a una ingloriosa ritirata sul fiume Volturno. Se a questo aggiungi delle madornali cantonate quando è il tuo giornale a citare importanti episodi storici, allora- come scrive il tuo Bertini- la frittata è davvero fatta. Ed è meglio che si bandiscano lasagne e ragù troppo densi per un più taumaturgico “Alka-seltzer”. Ad ogni buon conto, non ho mai propalato ai telespettatori che Garibaldi a Teano pronunciò testualmente “obbedisco”, che invece espresse quel concetto (pronunciare = esprimere qualcosa con ossequio, “Devoto-Oli”) lo andremo a dimostrare in modo probante e testi alla mano. Semmai ho cercato di spiegare in pillole, con i tempi televisivi, un piccolo pezzo del nostro Risorgimento.
Ma andiamo con ordine chiedendo scusa a chi leggerà per la non brevità dei ragionamenti che, una volta abbandonata la sintesi di un servizio tv, pretendono argomenti solidi e richiamo puntuale alle fonti. Sicché, gentile direttore, la storia –come la lingua italiana - è lastricata di insidie: il tuo Bertini scrive a confutazione del mio servizio che “obbedisco è il testo del telegramma con cui nel 1866, all’epilogo della Terza guerra d’Indipendenza contro l’impero austro-ungarico, Garibaldi fermò i suoi uomini che muovevano verso Trento perché ormai Vittorio Emanuele II aveva firmato l’armistizio di Cormons”. Galeotto fu il telegramma del Condottiero spedito il 9 agosto 1866, la pace firmata presso Gorizia dal generale Petitti Bagliani di Roreto è del 12 agosto 1866. Quindi l’accordo armistiziale fu firmato 3 giorni dopo l’invio del telegramma, non prima, come invece prosa e consecutio temporum del tuo corsivista lasciano inequivocabilmente intendere. Ci sono tre giorni o parimenti 72 ore di distanza temporale tra Bezzecca e Cormons. Sulla collinetta del Vomero dove risiede la redazione del tuo giornale siamo alla fantastoria! Avete indossato un elmo di Scipio sbilenco! Date fondo a imprecise reminiscenze da studiosi sul Bignami!. Chapeau…
Torniamo così alla disfida dell’obbedisco, a me e al tuo collaboratore con incomprese doti storiche tanto cara. Ti ribadisco punto per punto ciò che ho scritto nel servizio sull’Unità d’Italia, forse dal sen fuggito al Catone-Bertini dei Due Golfi, e ti spiego con dovizia di particolari e di rimandi storici il perché. Per iniziare leggiamo questa “sorprendente” prolusione: “Garibaldi è stato definito da autorevoli storici un rivoluzionario disciplinato. Lui, repubblicano, che consegna l’Italia meridionale al re Vittorio Emanuele II. Lui, che pronuncia obbedisco, frenando il suo impeto per la liberazione di Roma, prima del tempo previsto dalla politica…”. È Franco Marini a parlare, ex Presidente del Senato della Repubblica, che in occasione del bi-centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, comincia così il suo intervento davanti all’assemblea di Palazzo Madama, allargata a storici e studiosi del Risorgimento (cfr resoconto sten. Senato della Repubblica, 4/07/2007).
La allora seconda carica dello Stato che brancola nel buio della storia?. Con la cocciutaggine cronachistica che ci contraddistingue andiamo a spulciare le fonti dell’epoca: “...Verso le ore 8 e mezzo antimeridiane il Re si trovava sulla Strada Caianello-Teano, al bivio della chiesa di Borgo, ivi gli andava incontro il Generale Garibaldi; cui il sovrano stringeva la mano. Vittorio Emanuele e il Dittatore procedevano quindi a fianco a fianco per circa dieci minuti, fino a Teano. A Porta Romana, si separavano. I due si parlarono da soli per circa 10-20 minuti, cosa si siano detti, sono tutte supposizioni, ma lo si può dedurre dagli avvenimenti che seguirono…”. (cfr cronaca dell’incontro di Teano, Quotidiano “Roma” n. 300 10/1860). “… Non tardò a giungere Garibaldi: sceso di sella, si pose sul davanti a guardare la truppa con lieta pupilla... all’arrivo del Re, cavatosi il cappellino, rimase il fazzoletto. Il Re stese la mano dicendo: Oh! vi saluto, mio caro Garibaldi, come state?". E Garibaldi: "Bene Maestà. E lei ?". Il Re: "Benone!". Garibaldi, alzando la voce e girando gli occhi come chi parla alle turbe, gridò: "Ecco il Re d’Italia”!. E i circostanti: "Viva il Re!". Vittorio Emanuele, trattosi in disparte pel libero transito delle truppe, si intrattenne qualche tempo a colloquio col Generale. Indi si mosse...”. (cfr “Garibaldi e i suoi tempi” di Jessie W. Mario, trascrizione dei documenti di Alberto Mario, soldato garibaldino partecipante alla spedizione dei Mille).
Dalla pedissequa trascrizione delle cronache si evincono due cose inconfutabili: pubblicamente il re e il generale si scambiarono convenevoli e Garibaldi riconobbe pienamente l’autorità del sovrano. Poi ci fu un colloquio privato che durò una ventina di minuti, quel che si dissero non è pubblico e testimoniabile, il tenore e la sostanza della conversazione lo si dedurrà, scrive il cronista del “Roma”, dai fatti che seguiranno (sogliono dire i giuristi: per tabulas). Com’è pacifico tra i ricercatori, la filologia applicata alle scienze storiche si prende la briga di studiare testi, documenti e testimonianze al fine di ricostruire attraverso una corretta interpretazione e sistemazione problemi, fatti, circostanze di ordine critico e storico non immediatamente intelligibili. Se così non fosse buona parte del patrimonio culturale dell’umanità non sarebbe mai giunto a noi. Basti rievocare la tradizione orale prodroma della letteratura francese “d’Oc”, le chanson de geste, e “d’Oil”, liriche trobadoriche sull’amore; e per passare di palo culturale in frasca la stessa scrittura postuma di alcuni vangeli - apocrifi e non - propone una rappresentazione che non si tramanda attraverso esclusive testimonianze o rispolverando rassicuranti documenti scritti e archiviati, ma anche e soprattutto ricorrendo, lì dove esige, a una ermeneutica più raffinata.
Diamola allora la parola agli studiosi: Nicola Tranfaglia, tra i più autorevoli storici italiani, certo non potrà essere accusato di collaborazionismo con i giornalisti del servizio pubblico quando scrive: “… Se Cavour, con l'appoggio del re Vittorio Emanuele, tesse a livello diplomatico la sua tela per ottenere dalle potenze europee, e in particolare da Francia e Inghilterra, il sostanziale consenso alla conquista dell'Italia centrale e meridionale, Garibaldi persegue con i suoi volontari un obbiettivo parallelo, sia pure con una visione diversa e divergente. Il primo vuol costruire un regno liberale e parlamentare, il secondo pensa a una repubblica democratica… A differenza di Mazzini e di altri profeti dell'Unità (da Cattaneo a Pisacane) Garibaldi fu soprattutto un uomo d'azione e un soldato e dopo l'incontro con i sansimoniani restò fedele a pochi e chiari insegnamenti. Nella politica parlamentare non si trovava a suo agio e lo dimostrò assai presto ritirandosi nell'amata Caprera, ma lottò tutta la vita per la democrazia e la repubblica. Qualcuno gli ha rimproverato l'obbedisco al re nell'incontro di Teano ma quello fu, senza dubbio, un atto di realismo a cui non si poteva sottrarre”. (cfr “Mito e storia di Garibaldi”, Nicola Tranfaglia, 9/2007).
Ad adiuvandum andiamo a riscoprire quanto pubblicato da Francesco Renda, storico di formazione marxista, in un articolo dal titolo: ‘La Sicilia dopo Garibaldi: una rivoluzione incompiuta’, apparso sul quotidiano “la Repubblica” il 28 luglio 2009: “…Dovremo invece ricordare l'incontro di Teano.. Se Garibaldi non avesse obbedito si sarebbe fatto ricorso alle armi. Sul fiume Volturno da un lato c'era l'esercito dei volontari garibaldini e dall'altro l'esercito sardo con alla testa lo stato maggiore militare e il sovrano. Il pretesto o il motivo complementare di quell'avverso schieramento fu che Garibaldi voleva marciare su Roma e questo avrebbe provocato l'intervento militare di Napoleone III. La ragione politica determinante, tuttavia, non fu quella o non fu solo quella. Il governo di Torino, presieduto dal conte di Cavour, era un governo di destra. Garibaldi era di sinistra, anzi era il principale esponente della sinistra europea. Garibaldi a Torino avrebbe rivoluzionato la geografia politica. L'Italia sarebbe stata un'altra. Questa non è fantapolitica o fantastoria, fu un problema reale che venne risolto a Teano in termini positivi per la questione romana, ma in negativo per aver provocato il sorgere della questione meridionale..”.
Dunque la storia degli storici fa definitivamente “iustitia” di Bertini, la ricostruzione di episodi non testimoniabili è asseverata dalle argomentazioni di due studiosi (ma se ne potrebbero citare moltissimi altri). È cioè frutto di una posizione univoca, indiscutibile, su fatti concludenti successivi all’incontro di Teano e coessenziale all’interpretazione autentica da dare al dialogo di un “soldato obbediente” al cospetto del suo comandante, il re d’Italia; suscettiva, quella conversazione così ermeneuticamente indagata, di enormi effetti politici sull’evoluzione dell’intero quadro risorgimentale.
Ma ritorniamo all’incipit del servizio su Garibaldi sbertucciato dal tuo Bertini, evidentemente incorso in una improvvida eterogenesi dei fini, proprio quando si inerpica, barcollante, sul sentiero impervio delle stoccate revisioniste: se non altro, e pur nel suo parossismo intellettuale, Ernst Nolte ("Controversie") si spinse a commisurare sul piano logico e fattuale lo sterminio di classe dei bolscevichi con l’Olocausto dei nazi-fascisti, qui al massimo saremmo all’epopea del Garibaldi sottomesso ai Savoia. Più che revisionismo, e come abbiamo ampiamente dimostrato, una ovvietà confutabile neanche da Popper. Ma Bertini e la storia, e questo sì lo abbiamo compreso, sono due separati in casa in attesa di divorzio. Andiamo comunque a rileggerle quelle righe irrise, riprendendole dal “grondante gerundio” che di solito, almeno per noi umili mestieranti dell’informazione, sorregge un discorso indiretto: “... Accettando con quel riverente ‘obbedisco’ al sovrano savoiardo, pronunciato a Teano, di non compromettere le conquiste fin lì ottenute…”.
Mi professo colpevole: “O obbedisco o morte”, parafrasando ancora l’Eroe dei due mondi volevo esattamente intendere quello che ho scritto, Garibaldi (non è lui che parla ma il giornalista per sintesi di un concetto di oggettivo dominio storico, altrimenti si sarebbe ricorsi al virgolettato e al discorso diretto) non scrisse il telegramma a Teano (ovvio), piuttosto il Generale nel famoso incontro espresse un ossequioso obbedisco da buon soldato nei confronti di Vittorio Emanuele II, suo comandante, incanalando la parabola risorgimentale sulla capitalizzazione delle conquiste ottenute dal Regno Sabaudo secondo i desiderata di Cavour. “La sua obbedienza quale espressione storicamente provata nella consequenzialità irrefutabile degli accadimenti” (citazione tratta dagli appunti di Storia Moderna, corso universitario di Scienze Politiche, anno ’87-’88, Ateneo “Federico II”, Napoli, docente Giuseppe Coniglio). A Teano Garibaldi obbedì al re nell’interpretazione degli studiosi, obbedì nella prolusione del Presidente del Senato della Repubblica, obbedì nella vulgata corrente, obbedì, buon ultimo, nello striminzito pezzullo del sottoscritto! Che poi, da soldato fedele, in quei 20 minuti di colloquio a quattr’occhi col suo sovrano abbia pronunciato un più militaresco “signorsì” o un improbabile e dialettale (era in Campania) “vabbuò Vittò, aggio capito”, sinceramente è materia che non interessa più gli storici (che hanno fatto la loro parte), né i giornalisti che raccontano (citando gli storici), ma che al più può essere spunto per una pièce teatrale.
Che cosa più dirti Direttore, rimango in laica attesa di una rappresentazione dialettica delle fulgide (ironico) pagine risorgimentali, anche in virtù di una datazione certa di questo benedetto e retrodatato armistizio di Cormons, vieppiù sulla discordia di un telegramma 'garibaldescamente' ritardato ad uso dell’argomentare del tuo collaboratore. E infine, lasciami umilmente vagheggiare che se proprio ci si impanca a maestro di musica e canto impugnando il legno dritto della bacchetta (ci perdonino la parafrasi kantiana), pur i composti Franti della redazione campana della Rai, al confronto rizelati giganti della speculazione teoretica, ambiscono alla pretesa che l’ultimo “prufessore e mandulino” rimasto tra noi, il collega Oliviero Bertini, non continui a mandare a memoria solo gli spartiti della pianola “Bontempi”.
“Siamo tutti ignoranti, la differenza è che non tutti ignoriamo le stesse cose". (A. Einstein). Perdonami, direttore, anche la citazione finale. Con i migliori saluti.
|