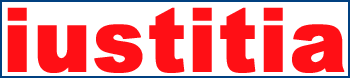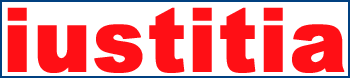|
|
Chi fa inchieste è sempre solo
|
ROBERTO PAOLO. Nato a Montesarchio, quarantasei anni a dicembre, da dodici professionista con alle spalle una laurea in Scienze politiche, nel ’95 è tra i fondatori del Corriere di Caserta, guidato da Pasquale Clemente. Il primo maggio ’98 è capo servizio nella nuova avventura editoriale di Clemente, La Gazzetta di Caserta. Il primo gennaio 2001 viene assunto al Roma e dal dicembre 2008 è redattore capo. |
|

Roberto Paolo |
|
Del film “E io ti seguo” non colpisce la storia, che pure pretendeva di esserne l’elemento principale, col suo carico di ambiguità, atrocità e ovvietà, ma restano impresse la bravura dell’attore protagonista, la pulizia del montaggio, l’adeguatezza della colonna sonora e soprattutto dei silenzi, che il regista sa maneggiare con precisione. E colpisce in generale la dimostrazione pratica, l’ennesima, di come sia possibile realizzare un ottimo lavoro senza soldi ma con passione, tenacia e competenza.
Resta scolpita la prova di Yari Gugliucci, che porta il fardello più grosso. E che pure riesce a restare intensamente umile. Ci restituisce la figura di un giovane e volenteroso giornalista, fragile, ingenuo e perciò esposto, generoso e perciò incosciente, tenace e perciò guardato con diffidenza. È Giancarlo Siani, il cronista del “Mattino” ucciso dalla camorra nel 1985. Gugliucci
|
.jpg)
Maurizio Fiume con Roberto De Francesco
|
riesce a non andare sopra le righe, a non cadere nella retorica, tranne forse nel primo incontro con l’amico-guida dell’Ansa (un Roberto De Francesco |
|
appassionato e però più incerto del solito, forse anche perché il suo personaggio è quello peggio definito dalla sceneggiatura).
La regia (di Maurizio Fiume, autore e produttore del film) tenta a tutti i costi di marcare una cifra stilistica personale con l’uso (e l’abuso?) dei campi stretti, strettissimi, primi piani di volti, di oggetti, con l’intento di rendere visivamente, fisicamente, un senso di oppressione, l’atmosfera asfissiante che avrebbe circondato Siani per le sue inchieste su politica e camorra. Ma che frammenta la fluidità del racconto, non lascia respiro. E la voluta claustrofobia che si crea, rischia di allontanare l’attenzione dello spettatore invece di conquistarla. Per fortuna, nel montaggio Fiume mostra una mano felice, che ridà al film l’aria e la velocità necessaria.
Anche la sceneggiatura ha i suoi alti e i suoi bassi, con poche sbavature nei dialoghi, generalmente asciutti e ben costruiti. C’è da dire che la materia non era facile. Fiume sceglie di creare del climax fin dall’inizio, per paura di annoiare, per l’ansia di tener desta l’attenzione dello spettatore. Così inserisce dei flash-forward (inserti di scene che sono temporalmente di molto successive al tempo corrente del film) che spiazzano chi non è ben al corrente di come andò nella realtà la vicenda. Ci sono però anche scene memorabili: la lenta sequenza del boss Nuvoletta che taglia la mela e distribuisce gli spicchi agli affiliati, come una sorta di blasfema “comunione”, merita una menzione speciale.
Certo, l’audio è da buttare: costringe anche l’orecchio migliore a non poca fatica o all’uso costante del telecomando per compensare le variazioni tra scena e scena, tra musica e parlato.
Ma non c’era Hollywood alle spalle, e nemmeno Cinecittà. A fare le pulci alla fattura del prodotto, sembra quasi di |
sparare sulla Croce Rossa. Tenuto conto degli scarsi mezzi a disposizione, il film è un miracolo di bravura: autore, attori e tecnici meritano tutti un giudizio ottimo.
Detto del piano tecnico ed artistico, resta tutto il resto. Perché questo non |
.jpg)
Torre Annunziata. Il circolo dei pescatori |
|
è un film di invenzione. Presume di raccontare “una storia vera”, come da titoli di testa (smentiti però nei titoli di coda, dove si afferma più cautamente che fatti e personaggi sono immaginari, mentre vero è l’ambiente che li ha prodotti, citazione “rubata” a “Le mani sulla città” di Rosi).
Mi pare che invece il film non centri l’obiettivo. Se voleva essere un film - inchiesta, doveva parlare di nomi e di fatti, anche se diversi dalla verità giudiziaria, doveva proporre un’ipotesi alternativa, una e una sola. Se voleva essere un film-denuncia doveva prendere una posizione chiara e precisa. Cosa che non mi sembra sia stata fatta. Per intenderci, il film per buona parte aderisce alla verità giudiziaria, la dà per certa. Poi però inserisce delle invenzioni narrative (il furto del dossier di Siani dalla redazione, ad opera di un caporedattore, il blitz dei camorristi in tipografia per “sequestrare” il libro-rivelazione di Siani di cui si perderà ogni traccia, eccetera) che ammiccano, lasciano intendere, ma mai affermano, di un terzo livello, di un complotto tra politica, poteri editoriali e camorra che per la verità resta un’ipotesi suggestiva e poco credibile. E, soprattutto, è un’ipotesi sconfessata da due pentiti, che si prendono la responsabilità di accusare i vertici dei clan Gionta e Nuvoletta, e non sembrano perciò avere timori reverenziali per nessuno. Si accenna ai rapporti torbidi tra il sindaco di Torre Annunziata e la camorra (finirà in cella e sotto processo per questo, ma il film non lo dice). Allora mi sarei aspettato di |
.jpg)
A Torre manifestazione degli studenti contro la camorra
|
conoscere nome e cognome, o almeno il partito politico, del sindaco dell’epoca (per la cronaca, si trattava di Domenico Bertone, del Partito socialista). E che fine ha fatto il suo processo? Almeno nei titoli di coda, si poteva darne un cenno. Sarebbe |
|
piaciuto questo lavoro d’inchiesta a Siani, lui che era così puntiglioso e ansioso di documentazione d’archivio? Posso permettermi di dubitarlo?
E c’è infine un “quarto livello” che il film tira in ballo, oltre alla matrice politico-camorrista. È la famosa polemica sul ruolo dei vertici del “Mattino” e dei colleghi di Siani nel preparare il terreno all’omicidio o comunque nell’isolare Giancarlo. Tesi che ha scatenato indignate reazioni da parte del quotidiano napoletano. Eppure, a vedere il film, a parte casi singoli ed esasperati, il “Mattino” non ne esce per niente male. Proprio al “Mattino” Siani trova spazio, amici, capi disinteressati che lo consigliano per il meglio, archivi a disposizione. E la sera della sua morte i colleghi inscenano una rivolta pretendendo per Siani l’apertura del giornale. Al “Mattino” gli danno una scrivania e una macchina per scrivere. Da abusivo? E dov’è lo scandalo? Siamo onesti: l’avessero data a me a 26 anni una scrivania al “Mattino”... E se a Siani non piaceva l’abusivato, c’erano chissà quante testate (il “Manifesto”, la “Voce della Campania”, perché no, “Repubblica”) pronte a fargli un contratto da praticante e a pubblicargli le sue inchieste su Torre Annunziata… O forse no?
Quanto al complotto, risulta francamente difficile credere (e il film nemmeno lo dice) che i capi del “Mattino” fossero al servizio della camorra della provincia. Le pressioni politiche? Il potente di turno che si lamenta? Cose simili non sono mai capitate solo a quelli che si limitano a passare i comunicati stampa. E forse neppure a loro. Il politico italiano, e quello napoletano in particolare, passa metà del suo tempo a lamentarsi della stampa e a vedere nemici in ogni redazione, persino quando non succede niente. E sui sindaci che “chiedono la testa” dei corrispondenti di provincia io potrei scrivere un’antologia. Da qui all’omicidio…
Un’ultima annotazione sul presunto “isolamento” di Siani in redazione. Ma chi fa inchieste è sempre solo, sempre isolato. Perché è per natura un |
rompiscatole. Non foss’altro perché rompe il quieto vivere, perché il suo lavorare “troppo” è una spina nel fianco degli altri (“Ma chi si crede di essere, questo? Non si stanca mai
|

Il sindaco Domenico Bertone al corteo degli studenti contro la camorra |
|
di fare la primadonna? Vuole fare carriera? Vuole farmi le scarpe?”…). E, del resto, chi va con la truppa, di inchieste non ne farà molte. È nella natura delle cose. Cosa pretendete, di fare inchieste e poi entrare in redazione tra due ali di folla che applaude? Ma andiamo… Poi capita che ti ammazzano, e subito si comincia a sospettare del vicino di scrivania. Per quanto mi riguarda, resto ai fatti. E i fatti sono differenti.
E quanto ai fatti, ce ne è solo uno, nella morte di Siani, che si può forse imputare per davvero al “Mattino”. Ma di cui nessuno parla. La pubblicazione del famoso articolo sull’arresto di Gionta, dove si fa risalire la cattura al tradimento di Nuvoletta. L’articolo che costò a Siani la condanna a morte da parte del boss additato pubblicamente (e ingiustamente, per quel che ne so) come un “infame”. Onestamente io credo, lapidatemi pure, che da caporedattore un’ipotesi come quella non gliel’avrei fatta pubblicare a Siani, a meno che il giovane apprendista cronista non mi avesse giurato e spergiurato di averla letta coi propri occhi, nero su bianco, in un’informativa di polizia o in un atto giudiziario. Ed in tal caso avrei preteso di precisare nell’articolo la fonte, sia pure genericamente, in modo che fosse chiaro che non si trattava di un’ipotesi del giornale ma che era contenuta in atti in possesso degli inquirenti.
Anche i camorristi, più dei politici, soffrono la sindrome del complotto. E guai se pensano che il giornale non è più un’istituzione obiettiva che fa il suo lavoro riferendo ciò che sa, guai se si convincono che il giornale sia diventato il portavoce di un clan contro un altro clan. Per quel che ho capito, accadde proprio questo con Siani. Tanto che nel film più volte un camorrista ripete: “Questo sta abbacchiato con Alfieri”. Per questo dico che quell'insinuazione non andava pubblicata (tanto più che poi la storia giudiziaria, mi pare di ricordare, ha confermato l'inesattezza della tesi sul tradimento di Nuvoletta). Sia chiaro: Siani era un collaboratore di 26 anni e la responsabilità non è sua, semmai dei redattori più esperti che avevano il compito di controllare i suoi pezzi e ben consigliarlo.
In Campania lavoriamo in una zona di guerra. In nessun'altra regione dell'Occidente industrializzato si rischia di morire (o anche “soltanto” di essere gambizzati o picchiati) per aver scritto un articolo. Nel Meridione d'Italia sì.
I lettori possono ignorarlo o fingere di ignorarlo, noi giornalisti no.
Non sarà “politically correct”, in tempi di santi ed eroi, ma è quello che penso. |
| Roberto Paolo |
|
 |
|